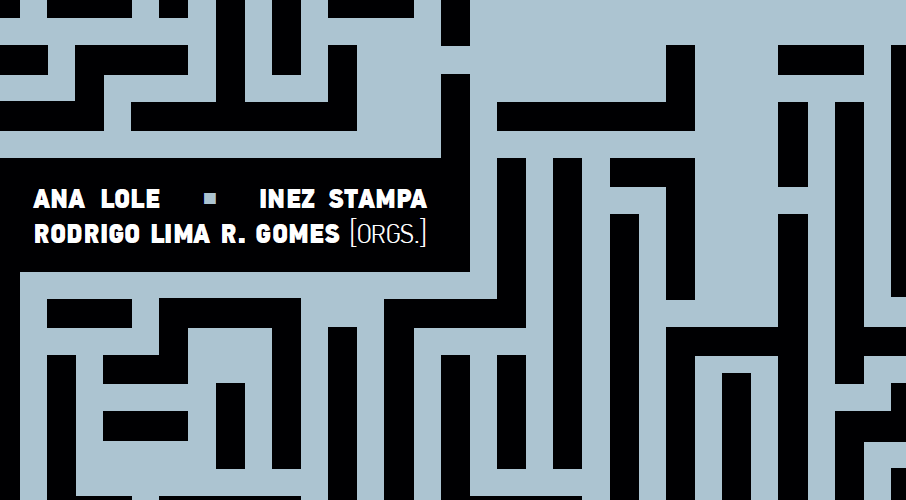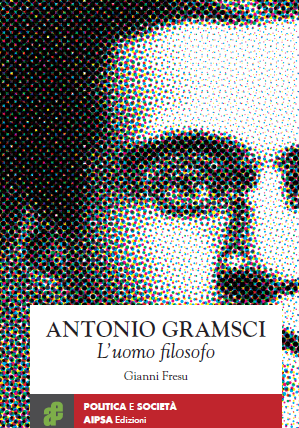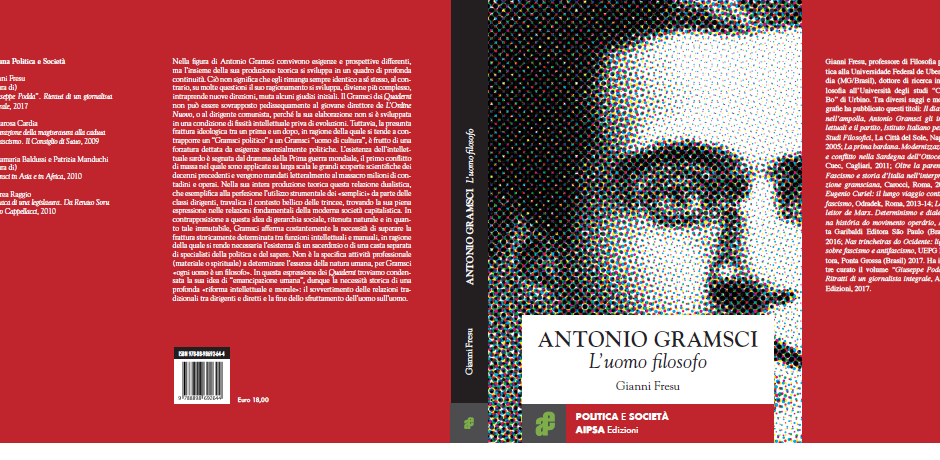Artigo presente no volume (e-book) Para Além da quarentena: reflexões sobre crise e pandemia, Ana Lole, Ines Stampa, Rodrigo Lima R. Rodrigues, Morula, Rio de Janeiro, 2020, ISBN 978-65-86464-13-9
Entre pandemia e crise orgânica:
contradições e narrações hegemônicas do capitalismo em colapso
Gianni Fresu
(professor de Filosofia Política da UFU/ presidente da IGS Brasil)
- A contradição entre capital e trabalho
Essa acumulação primitiva desempenha na economia política aproximadamente o mesmo papel do pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e, com isso, o pecado se abateu sobre o gênero humano. Sua origem nos é explicada com uma anedota do passado. Numa época muito remota, havia, por um lado, uma elite laboriosa, inteligente e sobretudo parcimoniosa, e, por outro, uma súcia de vadios a dissipar tudo o que tinham e ainda mais. De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi condenado a comer seu pão com o suor de seu rosto; mas é a história do pecado original econômico que nos revela como pode haver gente que não tem nenhuma necessidade disso. Seja como for. Deu-se, assim, que os primeiros acumularam riquezas e os últimos acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele. E desse pecado original datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo seu trabalho, continua a não possuir nada para vender a não ser a si mesma, e a riqueza dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar.[1]
Em meio à pandemia de covid-19, uma das argumentações mais recorrentes espalhadas pela nova Internacional da direita coordenada por Steve Bannon, que tem entre os seus afiliados Trump, Bolsonaro, Orbán e Salvini, é a necessidade de retomar as atividades produtivas. “A vida não pode parar”, como nesses dias eles vão repetindo, apesar do drama que atinge a realidade atual onde o dado mais visível é que a vida, sem os devidos cuidados e um planejamento político emergencial racional e fundamentado nas indicações da ciência, não apenas pode parar, mas acabar. Dentro dessa narrativa, segundo a qual o verdadeiro perigo mortal seria o colapso econômico, não temos apenas a tentativa de evitar uma crise que abalaria os respectivos governos de Trump e Bolsonaro, mas também uma operação hegemônica. Afirmando que é preciso voltar ao trabalho, essa retórica levanta o problema da sustentação econômica das classes populares apresentando seus propagandistas como defensores dos interesses materiais dos trabalhadores ameaçados pelas indicações da OMS e pelas providências dos governadores que limitaram a “liberdade de iniciativa econômica”.
Claro que tanto o Presidente quanto os empresários, empenhados nessa campanha a favor da reabertura das atividades, são hábeis em ocultar como essa crise tornou ainda mais evidente a contradição entre capital e trabalho. Para além das funções hegemônicas e demagógicas, o desespero do mundo dos negócios e a vontade avassaladora de reabrir fábricas e trazer os trabalhadores de volta à produção, confirmam uma verdade que, embora questionada desde o século XIX, não cessa de se manifestar: sem a exploração do trabalho não há lucro, sem lucro não há capital. Embora tenham tentado durante anos decretar a morte cerebral do velho Marx, alegando que o capital tem novas formas de remuneração totalmente independentes do salário, na realidade, o lucro não pode existir sem a exploração do trabalho. Por outro lado, se não fosse assim, não se explicaria por que estão sempre à procura constante de mão de obra barata a ser explorada nos países em desenvolvimento e prontos para relocalizar sua produção, nem por que, após cada crise, sua receita de política econômica permanece inabalavelmente a mesma: aumentar a produtividade e reduzir os custos de mão de obra.
Depois do prolongado colapso da economia mundial começado em 2008 nos Estados Unidos, que mostrou a natureza aleatória e fraudulenta do sistema especulativo financeiro, a pandemia jogou novamente o capitalismo numa crise orgânica internacional, abalando todas as certezas e as convicções do mundo ocidental, pondo em questão o paradigma neoliberal, que fora assumido acriticamente nas últimas décadas como única opção possível e legítima para os rumos do desenvolvimento histórico. Diante dos efeitos combinados da pandemia e da crise econômica, a contradição entre o direito ao lucro privado e o interesse geral tornou-se cada vez mais evidente. Apenas onde o poder público conservou um papel forte diante das pretensões do mercado, essa crise está sendo enfrentada com sucesso. Onde, pelo contrário, prevaleceu o domínio ideológico da metafísica do mercado, ou seja, a convicção segundo a qual intervir com medidas públicas no livre desenvolvimento da lei da oferta e da procura não passa de pura blasfêmia, tudo se tornou mais complicado. Nos países marcados pela contradição entre miséria absoluta e imensas concentrações da riqueza econômica, nos quais prevalecem a especulação e a lucratividade privada sobre as atividades eminentemente públicas (educação, universidade, saúde, pesquisa, sistema de aposentadoria, políticas de assistência e inclusão social), estamos observando um autêntico fracasso, que alcança proporções inimagináveis se comparamos com a situação de cinco meses atrás.
- A transfiguração ideológica da realidade
A mística do mercado, que subordina o homem à ilusão ideológica da “mão invisível”, é a forma mais sistemática e alienante de totalitarismo criada pelo homem. Um artifício retórico que consegue apresentar o direito à exploração do homem como uma filosofia de liberdade, e não de escravidão. O paradigma do egoísmo absoluto, tornado universal por um hábil trabalho ideológico de reconstrução interessada da realidade, é uma lei de ferro que produz riqueza para poucos e miséria para os demais. A suposta superioridade econômica do liberalismo é um escárnio colossal; a vitória dos netos de Adam Smith se dá em terreno hegemônico, por meio da auto-apologia, certamente não do lado do bem-estar e da riqueza social. Marx e Engels trataram não apenas das condições materiais no fundo dos acontecimentos históricos, eles investigaram a função política das ideologias em relação à tarefa da defesa e da conservação dos equilíbrios passivos tradicionais entre as classes. A história, a filosofia, o direito, a economia, a religião e todas as representações espirituais da realidade tornam-se instrumentos de governo de uma classe sobre as outras, por meio das quais cria-se um conformismo social entre os dominantes e, ao mesmo tempo, se arregimentam os dominados garantindo sua passividade. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, então, essa classe é ao mesmo tempo a força material e espiritual dominante, porque não controla apenas os meios de produção material, mas dispõe também dos meios de produção espiritual. Essas ideias, portanto, sempre se tornam a expressão ideal das relações materiais dominantes, concebidas como ideias que marcam uma inteira era histórica. Estritamente entrelaçada a essa função especializada de produção, Marx e Engels sublinharam a centralidade da separação entre trabalho espiritual e material:
A divisão do trabalho expressa-se também no seio da classe dominante como divisão do trabalho espiritual e material, de tal modo que no interior desta classe uma parte aparece como os pensadores desta classe (seus ideólogos ativos, conceptivos, que fazem da formação de ilusões desta classe a respeito de si mesma seu modo principal de subsistência), enquanto que os outros relacionam-se com estas ideias e ilusões de maneira mais passiva e receptiva, pois são, na realidade, os membros ativos desta classe e têm pouco tempo para produzir ideias e ilusões acerca de si próprios.[2]
- O capitalismo vive porque são os homens que lhe dão vida e o fazem viver
O capitalismo não existe por causa da objetividade implacável de suas leis, assim como jamais será superado única e exclusivamente por causa de suas contradições internas. Esse modo social de produção sobrevive à sucessão de suas crises devastadoras, não pela inegável eficiência econômica de seus equilíbrios, mas porque os homens o mantêm vivo mesmo através de terapias intensivas e, se necessário, por meio de involuções autoritárias (a era do fascismo). Isso porque o capitalismo (além da dominação) não é apenas economia, é também política, filosofia, relações hegemônicas, ou seja, um formidável arsenal capaz de transfigurar a realidade (dando a aparência de universalidade a certos interesses particulares) a ponto de tornar-se a miséria e a exploração “consensualmente” aceitas pelo miserável e pelo explorado[3].
Tanto o liberalismo clássico (segundo o qual o capitalismo não seria um sistema artificial, mas uma realidade objetiva independente da vontade humana, determinada “naturalmente” pelas leis da oferta e da procura) quanto o determinismo marxista (durante anos convencido de que esse sistema econômico burguês entraria em colapso por causa de suas contradições internas) compartilham a mesma visão metafísica das coisas. Cada modo social de produção sempre é o fruto de uma complexa combinação de elementos objetivos e subjetivos em que o fator econômico é sem dúvida predominante, mas não o único. Historicamente, a sociedade burguesa se afirmou no plano econômico e ideológico, no sentido de que era o resultado de uma autodeterminação material e espiritual com a qual essa classe conseguiu escapar tanto das regras corporativas da antiga sociedade feudal (conquistando sua autonomia econômica) quanto da visão de mundo da aristocracia feudal (afirmando o princípio da dignidade humana universal em oposição ao particularismo feudal, que determinou o status legal em razão do nascimento)[4]. O segundo elemento é certamente (em geral) colocado em condição de dependência em relação ao primeiro, mas isso não significa que seja secundário[5]. Por tudo isso, esperar que o capitalismo seja superado por suas contradições internas, quase sem esforço de luta, portanto, sem a irrupção da vontade ativa das massas, sem política e ideologia, significa atribuir a esse modo social de produção uma existência autônoma, independente da vida humana, para torná-lo uma divindade que, por sua natureza transcendente, existe não por causa da vontade humana, mas como consequência da fatalidade das coisas. O velho determinismo socialista veiculou Marx por meio de Darwin e aplicou à história a dinâmica evolutiva das ciências naturais, chegando à conclusão de que a humanidade passaria do feudalismo ao capitalismo e, portanto, ao socialismo, por razões internas às leis da economia, evidentemente, assim como na evolução da espécie passa-se do símio ao homem. As consequências políticas dessa concepção foram três: 1) atribuir aos protagonistas de sua emancipação (o proletariado) uma função totalmente secundária em relação aos líderes encarregados de entender essas leis e enxergar, dentro delas, a hora fatídica da “crise final”; 2) a ideia de que não se deve fazer a revolução, mas preparar sua implacável inelutabilidade, acumulando forças; 3) a convicção de que toda a humanidade estava destinada a viver os mesmos processos evolutivos, pois era necessário percorrer o caminho da via crucis do capitalismo (a civilização industrial do tipo ocidental) para passar à integral emancipação do homem. Este terceiro termo levou o movimento socialista a desinteressar-se da questão camponesa e da questão colonial, a ponto de olhar positivamente para a função civilizadora e modernizadora do imperialismo ocidental. Todos esses três termos foram literalmente varridos pela Revolução de Outubro, e, mais genericamente, todo o conceito de positivismo determinista foi duramente contestado não apenas por Lênin, mas pelo próprio Friedrich Engels:
Segundo a concepção materialista da história, o fator que em última instância é determinante na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso nunca foi afirmado nem por Marx nem por mim. Se agora alguém deturpa as coisas, afirmando que o fator econômico é o único determinante, transforma aquela proposição em uma frase vazia, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos momentos da superestrutura […] exercem sua própria influência no curso da luta histórica e, em muitos casos, determinam sua forma predominante. Há uma ação recíproca de todos esses fatores, e é através deles que o movimento econômico termina por afirmar-se como elemento central em meio à infinidade de acontecimentos acidentais […], se assim não fosse, a aplicação da teoria em um determinado período da história seria mais simples que a mais elementar equação de primeiro grau[6].
- A queda da religião da liberdade e o relativismo liberal
O capitalismo é um modo de produção social historicamente determinado, portanto, historicamente superável como qualquer produto humano. A questão é que, por sua própria e íntima natureza, esse sistema não só é profundamente revolucionário (sempre pronto para mudar as técnicas de produção, as formas de distribuição, as relações sociais e institucionais), mas tem um arsenal material e imaterial (hegemônico) que nenhuma forma social jamais teve antes na história.
Tendo claro tudo isso, a atual crise nos mostra a necessidade de concentrar nossa investigação crítica não apenas nas contradições da estrutura econômica, mas nos aparelhos hegemônicos por meio dos quais molda-se a opinião pública. Estamos vivendo uma fase de gravíssima crise sanitária e política que atinge de forma combinada o Brasil e o mundo, em que tanto a vida das pessoas quanto as liberdades democráticas estão em perigo diante das constantes tensões entres os poderes do Estado e das recorrentes tentações autoritárias que permeiam parte significativa das classes dirigentes e da sociedade brasileira.
Antigamente o liberalismo se definia de início por sua devoção filosófica à “religião da liberdade”. Assim, Benedetto Croce, um dos maiores filósofos do liberalismo no século XX, enfatizando que essa doutrina não pode ser contrária, em princípio, à “socialização e [à] estatização dos meios de produção”, ressaltou que a convergência entre liberalismo político e liberalismo econômico foi apenas de natureza empírica e provisória, rejeitando a tendência de apresentar as duas dimensões como idênticas:
Como já deveria ser pacífico, o liberalismo não coincide com o chamado liberalismo econômico, com o qual teve apenas concomitâncias, e talvez ainda tenha, mas sempre com uma aparência provisória e contingente, sem atribuir à máxima de deixar outro valor que não o empírico, como válido em certas circunstâncias e não válido em circunstâncias diferentes. Portanto, nem pode rejeitar em princípio a socialização ou estatização dos meios de produção, nem sempre a rejeitou no fato de ter feito, de fato, bastantes obras desse tipo.[7]
Quando isso aconteceu, a recusa foi determinada por razões práticas, não teóricas, ou seja, pela convicção de que tal escolha em determinado momento (não em termos absolutos) poderia ter deprimido a economia gerando um empobrecimento geral sem reduzir as desigualdades. O julgamento de qualquer reforma, segundo Croce, depende antes de tudo de um fator: se ela promove ou restringe a liberdade e a vida dos homens. A devoção à religião da liberdade levou John Stuart Mill a definir o liberalismo inicialmente como recusa de qualquer monismo de valores ou conformismo intelectual, que pelo contrário prevalece prevalente na cultura liberal de hoje:
Se todos os homens, exceto um, tivessem a mesma opinião, e apenas um fosse de opinião contrária, a humanidade não teria maior justificativa para silenciar esse homem do que ele teria, se tivesse o poder, para silenciar a humanidade […] o mal singular de silenciar a expressão de uma opinião é que isso rouba ao gênero humano, tanto a posterioridade quanto a geração existente, e aqueles que discordam da opinião ainda mais do que aqueles que estão de acordo. Se a opinião é correta, a humanidade se priva da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se errada, perde aquilo que quase constitui um grande benefício; ou seja, a percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade, produzida pela sua colisão com o erro.[8]
Falando de outro autor liberal clássico, Isaiah Berlin, o alvo central de sua obra é o pluralismo dos valores, a convicção de que as visões do mundo que inspiram a vida dos seres humanos sejam não apenas muitas e diversificadas, mas, em vários casos, inconciliáveis e até incompatíveis. Tanto ao nível das culturas gerais quanto em relação aos valores de uma mesma cultura ou pessoa. Seria característico das grandes religiões e das ideologias monistas achar que existe apenas um jeito correto de viver, uma só estrutura de valores de verdade, ou seja, afirmar, de forma fanática e indiscutível, a unicidade de uma tese que inevitavelmente desemboca na perseguição dos valores críticos ou não homologados. O pluralismo seria o único antídoto ao fundamentalismo, uma fonte perene de liberalismo e de tolerância que nunca pretende apagar as outras visões do mundo por ter vieses alternativos a nossas convicções mais profundas[9]. Por concluir com este tema, John Rawls escreve que uma sociedade liberal bem ordenada e regulada por uma concepção política de justiça (como equidade) assim o pode ser apenas dentro de um quadro de razoável pluralismo. Outro objetivo do liberalismo político é descrever como deve ser concebida e quais bases de unidade social deve ter uma sociedade liberal bem ordenada, cuja articulação torne possível o relacionamento dialético entre visões políticas razoavelmente diferentes. A cultura política de uma sociedade liberal democrática é sempre marcada pela presença de diversas doutrinas religiosas, filosóficas e morais em conflito: dialética que o liberalismo considera resultado inevitável do livre exercício das faculdades da razão humana[10].
Um sinal inequívoco do refluxo democrático desses anos nos é dado pelas contradições do mundo liberal, justamente no que diz respeito à questão das liberdades. A dimensão econômica (liberalismo) ocupou definitivamente toda a cena, de modo que a devoção à metafísica do mercado leva os liberais de hoje a considerar sagrada apenas a liberdade de iniciativa econômica. A esfera político-filosófica liberal, por outro lado, acabou encolhendo tanto que o tema das “liberdades fundamentais” parece ser simples retórica em defesa do mero individualismo econômico. Assim, hoje, aqueles que se autodenominam liberais olham com irritação mal disfarçada para as reivindicações de liberdades civis, sexuais e religiosas, bem como para a ideia de pluralismo político, cultural, filosófico e científico. Em suma, eles não suportam o poder público quando se trata de seus negócios, mas gostariam de um Estado autoritário e inquisitorial para comprimir todas as liberdades humanas, exceto a econômica, é claro.
A ideia de uma relação inversamente proporcional entre a esfera da liberdade e a extensão das atividades do Estado tornou-se dos mais duradouros mitos ideológicos, que tornam comum as concepções do “governo limitado” de John Locke e as teorias sobre o totalitarismo de Hannah Arendt. A condenação preventiva ou póstuma à ambição de regulamentar a vida social, intervir na economia e fornecer uma direção social à vida de uma comunidade nacional está diretamente entrelaçada com a mais eficaz representação ideológica do pensamento liberal: a capacidade natural de autorregulamentação das leis do mercado, teoricamente não compatível com a artificial irrupção ordenadora da política. Mas, como escreveu Gramsci, atrás dessa visão o erro teórico justifica-se pelo interesse prático:
A abordagem do movimento de livre comércio baseia-se em um erro teórico do qual não é difícil identificar a origem prática: na distinção entre sociedade política e sociedade civil, que é feita e apresentada como uma distinção orgânica. Assim, afirma-se que a atividade econômica é própria da sociedade civil e que o Estado não deve intervir na sua regulação. Mas, como na realidade a sociedade civil e o Estado coincidem, é preciso estabelecer que o liberalismo econômico é uma regulamentação de caráter estatal, introduzida e mantida por meios legislativos e coercitivos: é um fato de vontade consciente, e não a expressão espontânea e automática do fato econômico.[11]
De acordo com essa visão do mundo, atividades reconduzíveis à iniciativa econômica autônoma de indivíduos privados não podem ser objeto de interferência política porque, “naturalmente”, as leis da oferta e da procura sempre encontram soluções mais adequadas, eficazes e eficientes do que qualquer hipótese de regulação social. A realidade mostra que tanto os grandes empresários quanto seus teóricos são a favor do liberalismo econômico quando pode gerar lucro, mas se tornam intervencionistas quando arriscam seus ativos, porque, assim que os bancos e as grandes empresas veem suas margens de lucro reduzidas, exigem intervenção pública para salvar a economia privada.
Essas situações dramáticas para a humanidade, se de nada mais servirem, são úteis para entender tanto as contradições do liberalismo quanto o relativismo de valores imanentes a essa doutrina: “se a economia cresce, os lucros são meus, entretanto, quando há uma crise, a queda é de todos”. Os lucros são privados, mas as perdas devem ser socializadas. Assim, se normalmente os apologistas do “privado é melhor” invocam o Estado mínimo, considerando blasfêmia a ingerência da política na capacidade “natural” do mercado de se regular, durante as recessões invariavelmente pedem a ajuda do público. Como escreveu Marx a respeito da crise do capitalismo de 1857, “é bom ver que os capitalistas, que tanto gritam contra o direito ao trabalho, agora exigem o apoio público dos governos em todos os lugares, e reivindicam o direito ao lucro às custas da comunidade”[12].
***
Concluindo, apesar das transfigurações ideológicas e das narrações hegemônicas que marcam tanto a luta política quanto o enfrentamento ideológico, como era inevitável, também os efeitos da covid-19 reproduzem um quadro social marcado por uma brutal e unilateral luta de classes (de cima para baixo). No início da pandemia, ouvimos jornalistas falando de um vírus democrático, que não olha a classe social dos atingidos. Nada mais errado. Pelo contrário, a pandemia está desmascarando ainda mais a estrutura oligárquica e classista do país, onde, justamente por tal estrutura, essa doença golpeia sobretudo os mais pobres. O coronavirus chegou ao Brasil de avião, veiculado pelos representantes daquelas mesmas “classes nobres” que hoje pretendem reabrir tudo para retomar as atividades econômicas, todavia, quem está pagando realmente a conta dos erros políticos e da insensatez social espalhada nesse período pelo Brasil são as periferias, as favelas, as áreas rurais largadas ao seu próprio destino e, nelas, os “homens condenados a comer seu pão com o suor de seu rosto”.
[1] Karl Marx, O capital: crítica da economia política, Livro I: O processo de produção do capital, trad. Rubens Enderle,, Boitempo, São Paulo, 2011, p. 960-1.
[2] Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemã, trad. Luciano Cavini Martorano, Nélio Schneider e Rubens Enderle, São Paulo, Boitempo, 2007, p. 47.
[3] “Até agora, a arte do governo nada mais tem sido do que a arte de despojar e escravizar a maioria em benefício de uma minoria; e a legislação nada mais tem sido do que o instrumento para erguer esses ataques sistêmicos. Reis e aristocratas fizeram seu trabalho perfeitamente: agora cabe a você fazer o seu.” M. Robespierre, “Discurso sobre o governo representativo”, 10 de maio de 1793, em A revolução jacobina (Roma, Editori Riuniti, 1967), p. 127 (a tradução deste trecho do italiano para o português é de minha autoria).
[4] “Desde este instante, a consciência está em condições de emancipar-se do mundo e entregar-se à criação da teoria, da teologia, da filosofia, da moral, puras. Mas ainda que esta teoria, esta teologia, esta filosofia e esta moral entrem contradição com as relações existentes, isso pode acontecer porque as relações sociais existentes se encontram em contradição com as forças de produção existentes.” Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemã, cit., p. 16.
[5] “A classe revolucionária, por já se defrontar desde o início com uma classe, surge não como classe, mas sim como representante de toda a sociedade; ela aparece como a massa inteira da sociedade diante da única classe dominante. Ela pode fazer isso porque no início seu interesse realmente ainda coincide com o interesse coletivo de todas as demais classes não dominantes e porque, sob a pressão das condições até então existentes, seu interesse ainda não pôde se desenvolver como interesse particular de uma classe particular. […] Toda essa aparência, como se a dominação de uma classe determinada fosse apenas a dominação de certas ideias, desaparece por si só, naturalmente, tão logo a dominação de classe deixa de ser a forma do ordenamento social, tão logo não seja mais necessário apresentar um interesse particular como geral ou ‘o geral’ como dominante.” Ibidem, p. 49-50.
[6] Friedrich Engels, Sul materialismo storico (Roma, Editori Riuniti, 1949), p. 75.
[7] Benedetto Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono (Bari, Laterza, 1965), p. 34-5.
[8] John Stuart Mill, Da liberdade individual e econômica (Barueri, Faro editorial, 2019), p. 30.
[9]Isaiah Berlin, Libertà (org. Henry Hardy, Milão, Feltrinelli, 2005), p. 62.
[10] John Rawls, O liberalismo político (São Paulo, Atíca, 2000), p. 46-7.
[11] Antonio Gramsci, Quaderni del carcere 13 (Roma, Editori Riuniti, 1975), p. 1.590.
[12] Carta de Karl Marx ao Friedrich Engels de 13 de novembro de 1857, em Karl Marx e Friedrich Engels, Carteggio (Roma, Editori Riuniti, 1972), vol. III, p. 58.