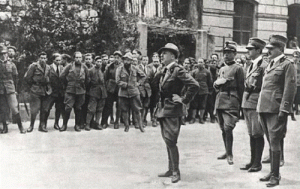Abbiamo perso? Vuol dire che non ci hanno capito!
È veramente triste fare i conti con il mesto epilogo di un progetto nato con l’ambizione di rifondare una teoria e una prassi comunista nel Paese, dopo lo scioglimento traumatico del PCI. Di sconfitta in sconfitta, l’organizzazione incaricatasi di rappresentare la palingenesi del marxismo militante si è progressivamente ridimensionata, fino a divenire inutile, residuale, insignificante. Altro che l’erede del più grande partito comunista dell’Occidente, al massimo ci siamo ridotti a scimmiottare una delle tante organizzazioni della vecchia sinistra extraparlamentare, con una non trascurabile differenza: allora c’era anche il PCI, oggi no.
Negli ultimi anni siamo stati impegnati, più che a costruire il nostro progetto politico e dargli credibilità, a ragionare in termini di posizionamento rispetto agli altri: PD sì, PD no; governo sì, governo no. Potremmo evocare la Sindrome di Stoccolma per spiegare l’attuale stato d’animo del PRC e del PdCI, perché la sconfitta e la profonda crisi del Partito democratico ha anzitutto spiazzato chi in questi anni ha incessantemente incentrato la propria azione politica sulla critica feroce o l’appiattimento verso questo partito. Se non esistesse più il PD un buon 70% degli argomenti al centro delle nostre discussioni, negli ultimi anni, verrebbe meno. Panico: chi siamo, dove andiamo, come fare?
Fondare o affondare il proprio progetto sulla politica delle alleanze (alleati sempre e comunque oppure mai) è indice di subalternità politica: in entrambi i casi il soggetto non sono io, bensì l’altro, in ragione del quale, in un senso o nell’altro, configuro tutte le mie scelte di tattica e strategia.
Come in più di un’occasione mi è capitato di dire, l’idea della rifondazione comunista è stata sconfitta non dalla borghesia, dai poteri forti, dall’ipoteca moderata nel Paese del Vaticano. Il PRC ha fatto tutto, o quasi, da solo: anzitutto perseguendo una linea a zig zag, eclettica, per non dire schizofrenica, dove abbiamo detto tutto e il suo contrario; quindi anteponendo sempre il momento elettorale a tutto il resto. Prima vengono i progetti politici e poi le urne. Noi abbiamo preteso di invertire questi due termini, andando avanti con campagne estemporanee, tirando ogni volta fuori dal cilindro conigli pronti a essere sacrificati nelle urne.
Siamo finiti nel girone dantesco dei Comitati elettorali, anziché impegnarci con continuità e coraggio su un progetto politico di lungo periodo in grado di seminare, sedimentare e poi, magari, ottenere risultati. La fretta per le esigenze della scheda elettorale, rispetto alle quali non ci siamo mai sentiti pronti e adeguati, tanto da dover ogni volta inventare un simbolo e contenitore nuovo, la fregola di eleggere, o meglio di essere eletti, ci ha puntualmente fregato. Ogni volta, a pochi mesi dal voto, abbiamo tentato la “mossa del cavallo” inventandoci il cartello elettorale di turno, per poi abbandonarlo subito dopo. È accaduto alle politiche del 2008, con la Sinistra Arcobaleno, alle elezioni Euoropee, con la Lista comunista e anticapitalista, in queste ultime elezioni dove, nel breve volgere di pochi mesi, abbiamo bruciato ben due soggetti inventati all’occorrenza, Cambiere si può e Rivoluzione Civile, dopo aver archiviato una proposta di cui nessuno ha più nemmeno memoria, il «Fronte democratico».
Al’interno di questa autentica “Via crucis” l’unico tentativo dotato di un minimo di prospettiva era la Federazione della Sinistra, su cui però non abbiamo mai investito seriamente, azzoppandola sin da subito con assurde competizioni interne, sgambetti reciproci, rivalità e insensati personalismi tra i nostri “piccoli leader”, l’esigenza di tutelare i rispettivi orticelli di sovranità anche a scapito del progetto comune. Eppure, proprio la sua nascita, all’indomani delle europee, qualche speranza e un minimo di entusiasmo l’aveva suscitata, perché finalmente si tentava di invertire la tendenza decompositiva delle scissioni a sinistra e perché, finalmente, almeno PRC e PdCI sembravano decisi a costruire una casa comune. Come tanti altri, ci ho creduto e ho dedicato parte non trascurabile del mio tempo e delle mie risorse a tale prospettiva, salvo poi scoprire, a pochi mesi dalle elezioni, che ci eravamo sbagliati e non era più temo di federarsi a sinistra. Da una parte e dall’altra, la politica delle alleanze è stata posta al di sopra di tutto, compresa l’esistenza stessa del soggetto politico. In entrambi i casi (sia per chi bramava gli accordi con il PD, sia per chi li rifiutava a priori), la malattia era la medesima: istituzionalismo e smania di protagonismo. In entrambi è stato un fallimento politico occultato dallo “stato di necessità” della fase.
Per quattro anni, da Roma, i nostri dirigenti ci hanno martellato (riunioni, assemblee, chilometri in auto, treno aereo, ore al telefono, soldi buttati, giornate sottratte a lavoro e vita privata) per fare avanzare il nuovo contenitore federale della sinistra di classe, spingendoci a girare i paesi, convincere i compagni, litigare con chi non ne condivideva la prospettiva. Poi, di punto in bianco, ovviamente a cose fatte, e senza alcun mandato congressuale, quel contenitore è stato svuotato e gettato nel cestino, senza neanche tentare di spiegarci come sono andate le cose o dirci, “scusate, ci eravamo sbagliati”.
Penso ci sia stata poca onestà verso i dirigenti e i militanti nei territori, perché mentre si dava loro l’indicazione di costruire la Federazione, i vertici dei due partiti maggiori facevano tutt’altro, evitando risolutamente di trasformare un cartello elettorale in soggetto politico. In realtà ho come l’impressione che nessuno di loro volesse realmente o credesse sinceramente in quel progetto. A meno di un anno dall’ultimo Congresso del PRC e a un anno e mezzo da quello della Federazione, si è deciso di comune accordo di sciogliere l’organizzazione, per diverse valutazioni sulle elezioni primarie e sulle politiche delle alleanze. Ovviamente il mandato congressuale diceva ben altro, ma nessuno si è curato di avviare una seria e serena discussione sulle ragioni di quel naufragio, con relativa assunzione di responsabilità, anzi, gli stessi che hanno condotto il battello negli abissi si sono incaricati di imbarcarci tutti in una nuova “Galera” all’insegna del motto “Cambiare si può!”. Hanno talmente preso sul serio questa esortazione da interpretarla in maniera tale da non sentirsi in dovere di giustificare le ragioni del “cambiamento posssibile”, o di accennare anche la più timida autocritica.
Forse sarebbe bene rileggerci le note dedicate da Antonio Gramsci al Generale Cadorna, una figura a suo modo rappresentativa della mentalità delle classi dirigenti italiane e un emblema della contraddizione tra governanti e governati: in politica come in caserma, per i gruppi dirigenti, una volta individuata la direttiva essa va applicata con obbedienza, senza discutere, senza sentire l’esigenza di spiegarne la necessità e la razionalità. Il «cadornismo» consiste nella persuasione che una determinata cosa sarà fatta perché il dirigente la ritiene giusta e razionale, e per questa ragione viene affermata come dato di fatto indiscutibile. La differenza però è che Cadorna, dopo Caporetto è stato rimosso e sostituito, chi dirige il nostro partito, nonostante una lunga sequenza di sconfitte umilianti, è sempre al suo posto.
Anche adesso, dopo l’ennesima catastrofe elettorale che ha travolto le ambizioni di una “rivoluzione civile” in questo Paese, lascia esterrefatti la totale mancanza di senso di responsabilità. Non solo non si analizzano le ragioni della sconfitta – anzi vengono messe in fila una lunga serie di alibi (l’oscuramento mediatico, la scarsa verve carismatica di Ingroia, il voto utile ecc. ecc.) degni delle invasioni di cavallette del miglior John Belushi – la segreteria nazionale del PRC si è presentata al suo Comitato politico nazionale con delle dimissioni farlocche, per poi tornare rapidamente in sella tanto da annunciare un Congresso. Ovviamente non subito, perché tanto di tempo ne abbiamo molto e magari nel mentre ci scappa pure qualche altra tornata elettorale. Macché, rinviamo tutto a dicembre, con la speranza di trovare sotto il prossimo albero di natale le masse popolari allineate e pronte per essere guidate dall’ennesimo “rilancio della rifondazione comunista”.
Questo gruppo dirigente ha avuto cinque anni per tentare sia questa strada, sia quella della più ampia aggregazione a sinistra, raccogliendo soltanto sconfitte. Avevo detto in tempi non sospetti che avrebbero dovuto fare serenamente i conti con i fallimenti di cui si sono resi protagonisti e dimettersi. Non lo hanno fatto, né allora né oggi, lo faccio io per loro, da semplice iscritto però, dato che agli incarichi dirigenti avevo rinunciato molto tempo addietro. Dopo 22 anni passati dentro il PRC ho deciso, non certo a cuor leggero, di non rinnovare la mia tessera, vi ero entrato alla sua nascita (che poi, vista l’età, politicamente era anche la mia) e mai avevo pensato, neanche nei momenti più duri di distanza, quando prevalevano gli elementi di dissenso a quelli di condivisione, di fare un simile passo. Lo faccio ora, con grande travaglio personale, per non rendermi ulteriormente complice di una conduzione tanto scellerata e, soprattutto, per non sprecare più il mio tempo. Bisogna finirla di pensare che abbiamo perso non perché abbiamo sbagliato, ma perché gli elettori non ci hanno capito. Forse, al contario, abbiamo perso sonoramente perché, invece, loro hanno capito benissimo mentre noi ancora no.