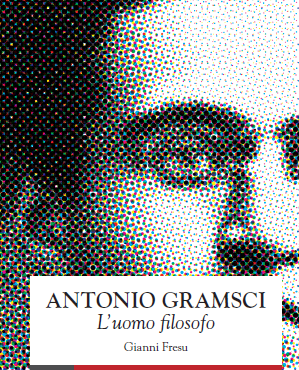La cronaca socio economica della nostra regione è quotidianamente segnata dalle vertenze del mondo del lavoro, nelle quali ha modo di manifestarsi l’agonia apparentemente irreversibile del suo superstite apparato produttivo industriale. Dalle miniere al tessile, dal siderurgico al pretrolchimico, praticamente non esiste comparto esente dallo stillicidio delle chiusure, con relative procedure di mobilità, ammortizzatori sociali e licenziamenti. Tuttavia, non intendo addentrarmi sul fenomeno della desertificazione industriale dell’isola, in sé noto e studiato da anni, bensì soffermarmi sulla condizione di solitudine vissuta dai soggetti che in primo luogo subiscono gli effetti di questo sgretolamento economico produttivo, costretti a forme di lotta sempre più disperate per attirare l’attenzione. Nella realtà sarda di oggi quanto resta della vecchia classe operaia si trova nella peggior condizione oggettiva e soggettiva di sempre dal suo sorgere, perché non solo subisce da decenni un processo di ridimensionamento strutturale, ma vive un drammatico isolamento politico. Per un verso, gli apostoli delle leggi di mercato (oggi prevalenti) la definiscono un residuo storico del Novecento, sopravvissuto solo grazie all’assistenzialismo statale e dunque ne affermano l’inutilità, sollecitando un rapido lavoro di inumazione al becchino. Per un altro, quel che resta della sinistra, insieme a una visione del mondo organica e coerente incentrata sul conflitto capitale lavoro, sembra aver smarrito anche una precisa idea dei suoi referenti sociali, pertanto, di fronte alla crisi in corso si limita a portare una solidarietà inane ai lavoratori, molto prossima a quella delle autorità ecclesiastiche, la visita del vescovo o del parroco al distretto in crisi e l’immancabile invocazione al signore. Infine, gli orientamenti impegnati nel rivendicare l’universo ideale della cosiddetta “sardità”, sovente prigionieri di una visione romantica “dei bei tempi andati” (intendendosi per essi la retorica dei rapporti sociali comunitari, propri del mondo agro-pastorale). Buona parte di loro, non tutti per carità, guarda con indifferenza se non proprio con malcelato disprezzo questo mondo, quasi che, nel suo storico farsi “classe in sé”, gli operai abbiano incarnato il tradimento di civiltà degli “originali” rapporti produttivi sardi. Qualcosa di molto simile all’approccio dei populisti (portatori anch’essi di una ideologia imperniata sulla mistica della piccola proprietà contadina) verso la nascente classe operaia russa di fine Ottocento. L’attuale solitudine della classe operaia sarda è drammatica, in sé persino più grave del suo disarmo strutturale, determinato dall’insieme combinato di due fattori dal pesante carico distruttivo: la tendenza storica alla delocalizzazione nella produzione industriale; la crisi organica del capitalismo mondiale, dunque le ristrutturazioni da essa generate. Insomma, non solo la classe operaia sarda sembra destinata a non avere più una progenie, non ha nemmeno padri. Ciò accade non solo nel mondo politico, ma anche negli ambienti incensati dell’Accademia, un tempo guida dei cambiamenti storici e ora rimorchio della più spicciola cronaca politica. Non è un caso se gli studi di uno storico di grande levatura come Girolamo Sotgiu, sulla nascita del movimento operaio sardo, siano praticamente dimenticati e anche i suoi allievi e discepoli si guardano bene dal continuarne l’opera. Eppure il comparire del movimento operaio nella nostra regione, a partire dalla costruzione delle strade ferrate nell’Ottocento, ha rappresentato un indubbio progresso in termini di soggettività sociale e politica, ha favorito l’uscita da una storica condizione di subalternità per fasce significative di masse popolari sarde, superando la illusoria rappresentazione del fantomatico “popolo sardo unito” (senza distinzione tra sfruttatori e sfruttati, dirigenti e diretti) oggi invece tornata prepotentemente di moda. Forse proprio in ciò bisogna rintracciare la convinzione secondo cui i mali del cosiddetto popolo sardo (povertà, arretratezza e sfruttamento) sarebbero una conseguenza della sua misconosciuta dimensione nazionale, anziché il frutto delle contraddizioni nei rapporti sociali di produzione in cui esso si situa. Anche questa confusione, a mio parere, è un segnale della vittoria egemonica di una parte di quel popolo e della sconfitta dell’altra.
Gianni Fresu