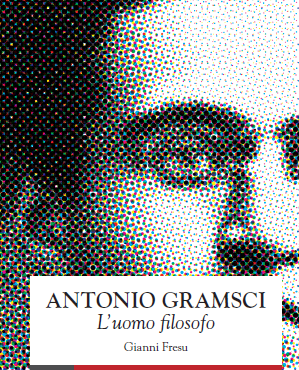Un’isola in ostaggio.
La trattativa Stato-mafia come pratica organica e permanente di autodifesa nella storia repubblicana.
Rileggendo le pagine più oscure della storia italiana nella seconda metà del Novecento, emerge come la Sicilia, tra strategia della tensione, Mafia, servizi segreti, si situi al centro di trame di cui è possibile comprendere il senso storico senza però conoscerne completamente la verità processuale. Oggi quelle pagine tornano di attualità, per l’inquietante coinvolgimento dei massimi vertici dello Stato in una trattativa scellerata con la mafia nel vivo della sua più efferata azione stragista. Più in generale, esiste un problema di verità storica e processuale, che riguarda il ruolo di apparati dello Stato e di servizi stranieri, in un arco temporale assai più ampio. Come oramai è noto a tutti, l’attività invasiva dei servizi segreti americani sul territorio italiano è nata con lo sbarco in Sicilia del 1943. Qui si ha anche l’inizio vero e proprio della strategia della tensione con la strage di Portella della Ginestra. L’antefatto della strage del primo maggio 1947 risiede nelle elezioni del 20 aprile per l’Assemblea regionale, segnate da un inaspettato successo del Blocco del popolo – (PCI, PSI, Partito d’Azione), passato dal 21% del 2 giugno 1946 al 30,4% – un arretramento della DC, che perse quasi il 13% dei voti, e il ridimensionamento di Monarchici, Uomo Qualunque e Movimento per l’indipendenza della Sicilia, vale a dire, le forze dietro cui si concentravano i gruppi di latifondisti e possidenti decisi a bloccare la strada a qualsiasi ipotesi di mutamento nei rapporti sociali delle campagne. Un risultato che s’inseriva in un generale processo di crescita politica e sindacale delle masse contadine siciliane, sfociato nelle occupazioni delle terre incolte e nel movimento rivendicativo per la riforma agraria. La manifestazione del primo maggio, con il comizio sul «sasso sacro in memoria di Nicola Barbato», riprendeva una tradizione le cui origini risalivano al movimento dei fasci siciliani, una festa popolare, e quell’anno assumeva un significato del tutto nuovo e particolare. Gli undici morti e cinquantasei feriti lasciati sul terreno erano il primo emblematico atto della guerra mossa ai movimenti di rivendicazione sociale in Italia nel dopoguerra. Questo episodio conteneva già gran parte delle chiavi utili a comprendere i successivi cinquant’anni di violenze e stragi impunite, con tutto il loro carico di complicità e coperture, provenienti dalle forze di sicurezza dello Stato italiano e degli USA. Una strage annunciata, preceduta dagli omicidi dei sindacalisti a Ficarazza, Partinico e Sciacca. Per uno strano gioco del destino, sempre in Sicilia sembra terminare, o forse intraprendere altri percorsi, la storia della rete operativa Gladio. Tra le tante anomale articolazioni di Gladio, che meriterebbero attenzione e ulteriori approfondimenti – specie ora che riemerge con consistenza l’ombra inquietante dei servizi segreti sulla strage del giudice Borsellino e della sua scorta – c’è sicuramente il Centro Scorpione istituito dalla struttura di Gladio a Trapani nel 1987, proprio nel periodo in cui si celebrava il Maxiprocesso alla mafia (sviluppatosi tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987). Le anomalie mai chiarite di questo centro sono molteplici, tuttavia, nel periodo e nel territorio in cui operò il Centro Scorpione vi furono alcuni omicidi eccellenti ed emblematici insieme: Giuseppe Insalacco (per tre mesi sindaco di Palermo nel 1984), protagonista di clamorose denunce delle collusioni tra mafia e politica, ascoltato anche dalla Commissione antimafia. Insalacco fu ucciso insieme al suo autista il 12 gennaio 1988. Dopo la morte fu trovato un suo memoriale in cui accusava diversi esponenti della DC palermitana, per la commistione con la mafia nel sistema di gestione degli appalti e del potere cittadino; il giudice Antonio Saetta, impegnato in numerosi processi alla mafia. Saetta in particolare si trovò a presiedere il processo a Giuseppe Puccio, Armando Bonanno, e Giuseppe Madonna, per l’uccisione al capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Il processo, conclusosi in primo grado con una sorprendente e molto discussa assoluzione, decretò, invece, in appello, la condanna degli imputati alla massima pena, nonostante i tentativi di condizionamento effettuati sulla giuria popolare, e, forse, sui medesimi giudici togati. Pochi mesi dopo questa sentenza, il 25 settembre 1988, il Giudice Antonio Saetta e il figlio Stefano vennero assassinati; Giovanni Bontate – fratello del boss Stefano, secondo i collaboratori di giustizia molto vicino ai vertici nazionali e regionali della DC, assassinato nel 1981 – coinvolto nel maxiprocesso e ucciso insieme alla moglie il 28 settembre 1988; Mauro Rostagno, impegnato nella lotta per il recupero dei tossicodipendenti in Sicilia e in prima linea nel denunciare gli intrecci tra mafia e politica, ucciso il 26 settembre del 1988. Ora, anche senza lasciarsi andare a troppe congetture, è quantomeno singolare che una struttura d’intelligencedotata di mezzi (persino un aereo e una pista d’atterraggio a propria disposizione), operante in quel territorio, non fosse stata in grado di reperire informazioni utili prima e dopo i diversi omicidi. Nella struttura peraltro operava un agente di spicco come Vincenzo Li Causi, coinvolto in diverse vicende poco chiare e dai profili decisamente illegali. Permangono insomma ampie zone d’ombra sulle effettive funzioni di questo centro operativo in una zona e in un periodo caldi, densi di avvenimenti drammatici. Dalla lettura degli atti sorgono spontanee quattro domande che ora, in una fase nella quale si discute con meno pudore della trattativa Stato-Mafia, sarebbe il caso di affrontare: la storia di Gladio, con la fine della guerra fredda, può dirsi realmente conclusa o semplicemente essa si è trasformata in altro? Può essere che la vicenda ad anello delle trame oscure in Italia in realtà non sia tale? Può essere che in Sicilia essa abbia avuto un primo ed un secondo inizio – conseguente al mutare dello scenario internazionale – piuttosto che un inizio ed una fine come in tanti hanno affermato? La storia italiana del dopoguerra è stata spesso interpretata con la chiave di lettura della «democrazia bloccata», in gran parte dei casi, ricondotta esclusivamente ai condizionamenti imposti dal fronteggiarsi sul piano internazionale dei due blocchi contrapposti. Se tutto questo trova puntuale conferma sul piano storico, non è comunque sufficiente a spiegare i limiti di funzionzmrnto democratico del Paese. Le pagine più oscure della «guerra a bassa intensità» combattute in Italia nell’epoca della guerra fredda avevano un concorso di cause solo in parte riconducibili a Roma, tuttavia, anche se si accettasse integralmente questa ipotesi, ciò chiamerebbe comunque in causa una debolezza congenita delle classi dirigenti italiane incapaci di resistere a sollecitazioni esterne di tale gravità. Una cosa è certa, l’utilizzo da parte dello Stato degli strumenti coercitivi legali e illegali e la pianificazione della strategia della tensione, per la difesa dello stato di cose esistenti, sono il segno evidente di un deficit di egemonia delle classi dirigenti in Italia. La trattativa Stato-mafia non può certo essere circoscritta alla stagione stragista dei primi anni Novanta. Come è oramai appurata la sinergia tra apparati dello Stato ed eversione neofascista per difendere gli equilibri politico sociali, consolidatisi a partire dalle elezioni del 1948, così il rapporto con organizzazioni malavitose come la mafia è un dato organico della storia di questo Paese, specie nelle sue fasi di crisi. Come altre volte in passato, la magistratura ha iniziato a fare chiarezza su certe inconfessabili modalità, del tutto antidemocratiche, di autodifesa del potere politico in questo Paese. Chiarite le verita processuali, speriamo, su questo dovranno interrogarsi gli storici in futuro, indagando senza blocchi e autocensure le storie individuali e collettive delle classi dirigenti italiane con tutte le loro contraddizioni. Il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia sarebbe potuta essere un’occasione propizia per iniziare a farlo, purtroppo, in gran parte, si è preferita strada dell’agiografia, la rappresentazione retorica e oleografica di un grande album di famiglia nel quale tutti gli italiani avrebbero dovuto riconoscersi.
Gianni Fresu