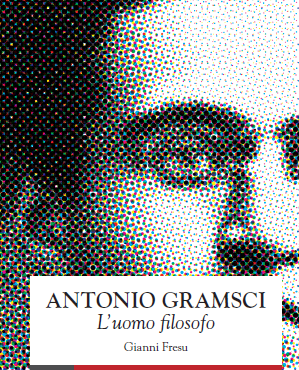Globalizzazione, liberalismo e falsa coscienza.
Congresso internazionale
Filosofia e globalizzazione
Internationale Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches Denken
Napoli (27, 28, 29 Aprile 2006)
A cavallo tra XX e XXI secolo il pensiero liberale ha autocelebrato il suo «definitivo» trionfo planetario, attraverso la definizione di quel nuovo paradigma delle relazioni interne ed internazionali che tutti abbiamo imparato a conoscere come globalizzazione. Ciò ha dato luogo, nel breve volgere di pochi anni, ad una mole imponente di studi, ricerche e pubblicazioni tramite le quali si era preconizzata una nuova fase per la storia dell’umanità nella quale, a seguito della liquidazione delle residue strutture pre-moderne, tutto era destinato fatalmente a mutare per l’effetto dirompente delle leggi di mercato, indomabili a qualsiasi tentativo ideologico di regolazione politica.
Nelle loro previsioni teleologiche sulle sorti progressive del liberalismo, gli iperglobalisti hanno descritto spesso la globalizzazione come una marcia inevitabile dell’umanità verso un’unica società, o civiltà, mondiale capitalistica. L’esempio più lampante in merito, come è noto, è quello di Francis Fukuyama, che già in un articolo del 1989 avanzava l’ipotesi che la democrazia liberale, oramai trionfante nei confronti delle ideologie rivali, si ponesse come «il punto d’arrivo dell’evoluzione dell’umanità», la «definitiva forma di governo tra gli uomini», «la fine della «storia». Questo perché la democrazia liberale – a differenza delle altre forme di governo, tutte affette da difetti e irrazionalità – si era dimostrata in ultima analisi priva di contraddizioni interne profonde.
Le tesi sulla «fine dello Stato nazione» e sulla natura transnazionale del capitalismo globale parevano dare una spiegazione plausibile alle novità più superficiali ed emergenti che venivano fuori dallo scenario internazionale con la fine della guerra fredda. In proposito potrei fare riferimento alla sterminata bibliografia esistente, ma per restare in Italia uno degli esempi più emblematici della vulgata liberale sulla globalizzazione, anche per il periodo in cui è stato scritto, è il numero monografico Global o no Global di Ideazione1, uscito nel settembre 2001, che contiene alcune chicche di questa stagione. Nel solco tracciato da Fukuyama, seppur con un’attenuazione delle sue aspirazioni finalistiche, Vittorio Strada introduceva in questo numero il tema del rapporto tra liberalismo e globalizzazione a partire da un’affermazione che di per sé è già una conclusione. La vittoria del liberalismo sul totalitarismo novecentesco, deve avere coscienza anzitutto della forma triplice che esso ha assunto storicamente: comunismo-fascismo-nazionalsocialismo. Tre varianti che hanno per Strada momenti di «profonda comunanza strutturale (…) concreti rapporti di reciproca influenza» dunque elementi di solida affinità, seppur nell’ostilità rivale, riscontrabili negli elementi costitutivi di tipo istituzionale (partito unico, ideologia statale, mobilitazione di massa), ma soprattutto nel fatto che tutti e tre avrebbero avuto quali nemici principali la democrazia liberale, il socialismo democratico, e la religione cristiana, cui ogni totalitarismo avrebbe contrapposto la propria religione politica.
Al di là dell’approssimazione di tale classificazione, facilmente scomponibile e rovesciabile su ognuno dei suoi elementi cardine, resta il dato che qui maggiormente ci interessa: la vittoria sul mostro totalitario a tre teste del Novecento è interamente attribuibile al fulgido trionfo del liberalismo democratico che ha assunto una posizione «centrale ed egemone». Trionfo che se anche non ha determinato la fine della storia, ha comunque sprofondato ogni velleità totalitaria nell’impetuoso sviluppo tecnologico del capitalismo. Dunque per Strada, come per una nutrita schiera di commentatori liberali, la vittoria sul totalitarismo non porta ad una semplice restaurazione del liberalismo classico ma ad un nuovo paradigma progressivo e globale: «Il nuovo liberalismo [scrive Strada] sarà in questo senso, critico e aperto a una dimensione sociale propria di un mondo massificato e diversificato, ma insieme globale e unitario»2. La storia, con la sua debordante ed irriverente velocità, si è incaricata di smontare in poche settimane queste previsioni, dato che il saggio e l’intero numero monografico di Ideazione venne scritto e stampato poche settimane (giorni) prima del fatidico “11 settembre”. Tutto quel che è seguito a quei tragici avvenimenti ha mostrato il vero volto tutt’altro che globale e transnazionale del capitalismo, rimettendo sul trono della storia (nel breve volgere di sei anni) la centralità dello Stato nazionale e dell’economia nazionale che tutti, Globalisti e no Global, davano per definitivamente superati. Certo oggi riaffermare simili congetture, dopo tre guerre per l’accaparramento delle risorse energetiche, e con le continue crisi tra le diverse economie nazionali nei settori strategici (vedi il recente scontro tra Francia e Italia sul versante energia), è un tantino più complicato, però, proprio per la maniera impietosa con cui la cosiddetta ironia della storia si è incaricata di demolirle, è veramente piacevole ripercorrere alcuni snodi dell’infatuazione transnazionale di Globalisti e no Global, mostrarne ingenuità e reciproche influenze.
È così, significativamente, la scheda di introduzione pubblicamente faceva professione di adesione all’approccio «equilibrato e politico» di Ernesto Galli della Loggia e, dopo aver rigettato la «contrapposizione manichea» tra Global no Global, prontamente designava un quadro concettuale che è bene oggi, a cinque anni di distanza riportare integralmente.
«l’universo globale nel quale viviamo non è che la risultante di tre direttrici: un’evento tecnologico comunicativo (internet, l’informazione planetaria in tempo reale; un processo economico finanziario (la libera circolazione di merci e capitali); un dato politologico (la fine dei blocchi ideologici, la crisi dello Stato-nazione, la rimessa in moto dei flussi di popolazione). La Globalizzazione è insomma il nostro presente e il nostro futuro. (…) Quello di un mondo completamente trasformato in cui, tra l’altro non ci sarebbe più spazio per imperi o superpotenze imperiali. Il potere è sempre infatti più disperso, nascono centri d’influenza sempre più numerosi e diversificati, lo spazio e il territorio non hanno più la centralità dei secoli scorsi, tutto va ripensato» 3.
Non c’è neanche bisogno di soffermarsi troppo per spiegare come i dati effettuali abbiano fortemente messo i contraddizione tutti gli assunti di questa analisi.
Sullo stesso copione si poneva anche Giuseppe Sacco, il quale ribadiva che il primo dato con cui si qualificherebbe la cosiddetta globalizzazione è la progressiva «cancellazione» degli Stati nazionali e l’affrancamento definitivo del capitalismo nei confronti dei fenomeni di condizionamento politico. Per condizionamento politico Sacco intende il fatto che con il trionfo della globalizzazione il mondo è infine «liberato dalle distorsioni politiche imposte dalla necessità di non lasciar spazio alla propaganda comunista», dunque con il venir meno di esso viene meno anche l’esigenza di una funzione di riequilibrio economico-sociale e di tutela giuridica e contrattuale della condizione di debolezza del lavoratore salariato rispetto al datore di lavoro.
Sacco distingue la globalizzazione e il movimento no global nel fatto che la prima attiene al campo concreto dell’economia e il secondo a quello politico ideologico, alla sfera delle idee. Così la globalizzazione è definita «un processo spontaneo tumultuoso che non ha obiettivi, ma solo una sua logica, che trae origine dall’aspirazione dagli uomini a migliorare il proprio destino e si realizza attraverso l’inesorabile meccanismo del mercato»4.
Dunque la globalizzazione intesa come entità dotata di vita propria, sganciata da qualsiasi direzione o connessione politica. Così come nel Settecento e nell’Ottocento l’economia politica e le leggi di mercato venivano presentate come rispondenti ad un ordine naturale, non storicamente e socialmente determinato, così, ora, lo stesso avviene per la cosiddetta globalizzazione. Il capitale transnazionale e leggi di mercato globale non hanno né un padrone né una radice nazionale.
In realtà anche la rappresentazione della globalizzazione appartiene appieno al mondo delle idee e il suo modo di accentuare certi aspetti e occultarne altri rientra nella sfera ideologica almeno quanto l’economia politica classica di Smith e Riccardo, con la differenza però che il globalismo ci offre un quadro concettuale molto più povero ed una aderenza alla realtà molto minore. Tutto questo mi porta ad affermare che il mito della globalizzazione – inteso come trionfo planetario spontaneo, naturale e non politico, delle leggi di mercato – si pone come una nuova forma di dissimulazione della realtà che tende a ometterne la natura storicamente e socialmente determinata. Il mito della globalizzazione dunque come nuova falsa coscienza dell’ideologia liberale.
Proseguendo la nostra lettura anche Carlo Jean, sebbene con accenti propri e a loro modo originali5 ripropone tutto l’armamentario classico dell’autocelebrazione liberale. Così la globalizzazione, oltre a favorire lo sviluppo economico del terzo e quarto mondo e i processi di universalizzazione del cosiddetto mercato globale, con l’erosione della sovranità sostanziale degli Stati, determinerebbe addirittura una «de-bellicizzazione delle relazioni internazionali». Certo è singolare che proprio Jean abbia parlato qui di «de-bellicizzazione delle relazioni internazionali» e dopo appena due anni sia stato uno dei più accaniti supporters della guerra preventiva6.
Ma è nel seguito del suo interessantissimo saggio che Carlo Jean ci mostra con chiarezza la vera finalità politica sottesa alle teorizzazioni sulla globalizzazione. Carlo Jean, infatti, ci dice prima che nell’era della globalizzazione la funzione dello Stato è quella di rendere «competitivi il proprio territorio, le proprie imprese e i propri cittadini, attirando i flussi di ricchezza», quindi afferma che «le risorse vanno concentrate sulle funzioni che sono rimaste essenziali, quali la sicurezza interna ed esterna [Jean non ci spiega però come ciò si concili con la supposta de-bellicizzazione delle relazioni internazionali di cui parla], la giustizia e, per l’appunto, l’aumento della competitività del sistema».
Scrive ancora Jean: «Le provvidenze della distribuzione vanno concentrate solo sui poveri e sui bisognosi, mentre il resto deve essere deregolato e privatizzato, nonostante l’esistenza di corporazioni [i sindacati dei lavoratori] chiuse nell’egoistica difesa dei propri privilegi»7. E così, la grande innovazione che la globalizzazione dovrebbe determinare nei ruoli della politica, si risolve in una novità che ricorda molto da vicino lo «Stato della spada e della toga», quello che si limitava a fare le leggi e a farle rispettare. La grande trasformazione-innovazione della globalizzazione porta dunque, dritta dritta, allo «Stato gendarme» ottocentesco, altro che innovazione.
Per lasciare il versante puramente ideologico di Ideazione, tra le produzioni scientifiche più valide ed interessanti sulla globalizzazione sicuramente c’è il lavoro collettivo Culture e conflitti nella globalizzazione curato da Elisabetta Batini e Rodolfo Ragionieri, composto da una serie di interessantissimi approfondimenti.
In uno di questi, Antony Mc Grew dedica la sua attenzione anzitutto alle diverse letture del fenomeno. Da quella di Giddens che considera la globalizzazione come la dinamica principale di cambiamento sociale della nostra epoca, a quella degli iperglobalisti che la vedono come un imperativo universale, alle diverse gradazioni di antiglobalismo, fino a coloro che interpretano la globalizzazione come mistificazione delle forze reali che stanno al fondo di dinamiche concrete e cambiamenti. Al di là delle differenti gradazioni secondo McGrew è bene trascendere gli aspetti più ideologicamente sterili del dibattito e giungere ad una concettualizzazione rigorosa della globalizzazione che non la riduca a mera logica economica, ma ne colga il carattere processuale multidimensionale, una concettualizzazione che sappia analizzare storicamente le forme della globalizzazione per indagarne dinamiche e interconnessioni spazio-temporali.
Il termine globalizzazione è soggetto a interpretazioni e definizioni tra loro profondamente diverse e contrastanti. In realtà le definizioni che vengono impiegate non necessariamente sono tra loro alternative, questo perché proprio la multidimensionalità della globalizzazione porterebbe ad una concettualizzazione a grappolo o mosaico, per la quale spesso le diverse definizioni finiscono per essere complementari, nel senso che ognuna di esse tende a svelare solo un aspetto di ciò che intende spiegare ma non la totalità del fenomeno. Dunque le tre varianti fondamentali che colgono rispettivamente gli aspetti materiali, spazio-temporali, e cognitivi della globalizzazione tenderebbero ad integrarsi vicendevolmente e non ad escludersi reciprocamente.
Anzitutto per McGrew la globalizzazione non denota semplicemente un mutamento in estensione e portata delle relazioni e attività sociali, essa comporta la riorganizzazione e la riarticolazione del potere economico, politico, militare e culturale. In secondo luogo, contrariamente alla vulgata prevalente che tende a presentare la globalizzazione come un qualcosa di assolutamente nuovo ed originale, McGrew ne mette in evidenza la natura processuale e dunque l’origine storica non certo recente. I processi di globalizzazione si avviano già nella fase della rivoluzione geografica e mercantile del 1500. Più precisamente vengono individuate tre fasi essenziali, «dal periodo pre-moderno, lungo la prima modernità (1500-1800), il periodo moderno (XIX e primo XX secolo) fino all’età contemporanea», tutte forme storiche differenti di globalizzazione in termini di caratteristiche geografiche, infrastrutture di potere, organizzazione. Secondo McGrew porre a confronto queste diverse forme storiche di globalizzazione è l’unico modo per individuare gli elementi nuovi.
Contrariamente alla tesi che identifica la globalizzazione con la «fine dello Stato», McGrew – che concorda con quanti parlano di limitazione alle sovranità classiche dello Stato moderno ma rifiuta la teoria sullo svuotamento (o erosione) di sovranità – ritiene che i fenomeni di interconnessione globale portino a far emergere semmai uno Stato ancora più attivista, dato che questo è costretto a «intraprendere intense collaborazioni e cooperazioni multilaterali» essendo coinvolto in strutture di governance globale e regionale. Il vero mutamento rispetto alla concezione vestfaliana di sovranità si ha dunque nel progressivo venir meno delle distinzioni tra affari interni ed internazionali, che portano i primi ad essere internazionalizzati e i secondi ad essere addomesticati: «gli Stati oggi non sono più mondi separati. Il crescente coinvolgimento in ordini regionali e globali e la proliferazioni di problemi che travalicano i confini ha creato comunità di destino che si sovrappongono (…) il comando e il controllo dello Stato dell’ideale vestfaliano è stato rimpiazzato dallo Stato riflessivo o reticolare che sta ricostruendo il suo potere all’intersezione tra sistemi globali, regionali, transnazionali e locali di governo e potere»8. L’autorità per McGrew è dunque articolata su diversi strati di governance nel quale collaborano un insieme di agenzie pubbliche e private. Per tutte queste ragioni non ha senso secondo McGrew parlare di svuotamento o erosione di sovranità statale, mentre lo ha parlare di trasformazione o riconfigurazione del potere e dello Stato.
A sua volta Robert Gilpin contesta l’idea secondo cui le forze transnazionali della globalizzazione economica avrebbero minato sovranità e funzione dello Stato nazionale e ribadisce invece che esso rimane, sia negli affari interni sia in quelli internazionali, il principale attore.
Così è vero che lo Stato-nazione è sottoposto ad attacchi che determinano profondi mutamenti, ma questi cambiamenti non sono orientati alla eliminazione degli Stati. Anche la sfida all’integrità politico-territoriale degli Stati lanciata dalle «politiche dell’identità» di aree etniche e regionali che lottano per ottenere la propria indipendenza – sfida particolarmente insidiosa a cavallo tra XX e XXI secolo – non mira all’eliminazione dello Stato ma al contrario alla costruzione di nuovi Stati indipendenti. Sicuramente le implicazioni transnazionali dell’economia hanno imposto dei mutamenti sul concetto di sovranità statale, ma per Gilpin sia l’estensione di ciò che viene definito globalizzazione economica, sia le sue conseguenze politiche, nelle diverse trattazioni sul tema, sono state notevolmente esagerate senza che si tenesse conto che, piaccia o non piaccia, quello attuale è sempre un mondo dominato dagli Stati. La realtà è per Gilpin ben più complessa di come in genere viene rappresentata.
La cosiddetta globalizzazione economica, oltre ad essere più limitata di quanto in genere non si riconosca, ha un impatto politico estremamente irregolare che varia profondamente da settore a settore. I servizi e la produzione industriale sono meno globalizzati della finanza, gli effetti della globalizzazione sulla sovranità statale variano profondamente a seconda della grandezza e della potenza economica della nazione. Così le grandi potenze come gli USA e l’Europa occidentale sarebbero molto meno soggette alle destabilizzazioni dei flussi finanziari rispetto a piccoli Stati. Secondo Gilpin si può dire che la globalizzazione non solo non ha eroso la sovranità statale delle grandi potenze, ma ne ha accresciuto l’importanza, specie in materia di competitività internazionale e liberalizzazione dei flussi di capitali e merci. Si pensi solo, a titolo d’esempio, alla funzione degli USA rispetto all’estensione degli accordi NAFTA in America Latina, o all’estensione dei principi del Trattato di Maastricht nell’Est europeo.
Come Gilpin anche Held, in Democrazia e ordine globale, contesta radicalmente la tesi sulla fine dello Stato nazionale. Per quanto i molteplici livelli di governance internazionale, possano produrre momenti di limitazione e disorganicità alle sfere tradizionali di esercizio delle sovranità statali, in definitiva questi spesso sembrano accrescere e non sminuire gli ambiti di intervento dello stato nazionale che, in ultima analisi, continua a rimanere il punto di riferimento anche nella fase attuale.
Ciò che viene superato nella globalizzazione secondo Held non è lo Stato nazionale ma bensì la polarizzazione classica tra le concezioni che attribuiscono alternativamente la titolarità della sovranità allo Stato o al popolo. Superamento che sarebbe, più complessivamente, il segno di una crisi degli approcci marxista e liberale al tema della sovranità. La globalizzazione per Held avrebbe messo a nudo i limiti e le unilateralità, da un lato del concepire la politica come una sfera eminentemente istituzionale, separata dalla società civile, che non deve interferire con le regole del mercato, dall’altra del considerare la realtà politica ed istituzionale come conseguenza immediata e diretta dei rapporti sociali di produzione che porterebbe a sottovalutare tutti quegli aspetti politico istituzionali non prontamente riconducibili alla struttura economica. Limiti e crisi che investirebbero per Held anche le rispettive gemmazioni contemporanee delle due ideologie: il cosiddetto neoliberismo degli iper globalisti e il comunitarismo della galassia no global.
Per Gilpin La globalizzazione ha avuto luogo storicamente ogni qual volta si è determinato un nuovo sviluppo nei trasporti, nelle comunicazioni e dunque nei commerci: «per migliaia di anni, idee, stili artistici e altri artefatti si sono diffusi da una società all’altra ed hanno spesso causato pericoli simili a quelli associati oggi alla globalizzazione economica9».
I processi di integrazione dell’economica mondiale che hanno caratterizzato questi anni, su cui tanto si è scritto, sono per Gilpin fortemente irregolari, limitati a certi settori economici, e si potrebbe anche dire che ci sono diversi aspetti per i quali il mondo attuale risulta meno integrato di quanto non lo fosse nel XIX secolo10.
«Nel primo anno del XXI secolo il mondo non è integrato come lo era sotto molti aspetti prima della guerra mondiale. Sotto il regime gold standard e l’influente dottrina del lasseiz faire, per esempio, durante i decenni precedenti la prima guerra mondiale, i mercati erano realmente più influenti ed i governi avevano poco potere sugli affari economici mentre oggi i governi nazionali hanno molti strumenti politici che permettono loro di gestire le proprie economie. Considerati in relazione alla dimensione internazionale, il commercio, gli investimenti e i flussi finanziari erano più estesi nel tardo Ottocento che oggi».
I cambiamenti che riguardano il XX secolo investono la forma e l’accresciuta velocità dei flussi economici attraverso i confini nazionali e l’inclusione di sempre più paesi all’interno dell’economia globale, ma per Gilpin la globalizzazione economica è per la più gran parte confinata nella triade USA, UE, Giappone, (forse bisognerebbe iniziare ad aggiungere India e Cina), al cui interno ruotano la stragrande maggioranza di profitti e strategie dell’economia mondiale. Se si escludono pochi paesi in via d’industrializzazione in Asia e America Latina e si differenzia il discorso per materie prime e risorse, la stragrande maggioranza dei flussi di investimento diretti all’estero vengono investiti negli USA, nell’UE, in Cina e India.
Il solo fenomeno rispetto al quale si possa parlare realmente e compiutamente di fenomeno globale è la finanza, ma anche essa per Gilpin necessita una qualificazione dato che buona parte di questa riguarda investimenti speculativi a breve termine e gli investimenti a lungo termine sono fatti con risparmi nazionali piuttosto che con risorse estere.
Per Gilpin due indicatori ci consentono di misurare il livello di integrazione globale: la «legge del prezzo unico» e il costo del lavoro. Per quanto riguarda il primo la considerazione preliminare è che c’è integrazione tra le economie quando beni, servizi hanno lo stesso prezzo. Ma la realtà dei fatti ci dice che i prezzi degli stessi beni differiscono enormemente a seconda dei parametri economici utilizzati per la misurazione e comunque resta un dato incontestabile che, ad esempio, due tra le economie teoricamente più globalizzate al mondo, USA e Giappone, abbiano prezzi di beni e servizi profondamente diversi. L’altro elemento che contraddirebbe la compiuta globalizzazione dell’economia riguarda il costo del lavoro che è contraddistinto da enorme disparità salariali e condizionato da limitazioni ai flussi migratori. I flussi migratori erano ben più significativi, di massa (milioni di europei che si spostano nelle Americhe e in Oceania e milioni di indiani e cinesi verso il sud est asiatico e l’africa), e globali nel tardo Ottocento che nella fase attuale.
Gilpin non si limita a contestare molti degli assunti centrali dei convinti globalisti liberali, ma fa notare come anche molti dei problemi che in genere vengono imputati dai cosiddetti no global alla globalizzazione in realtà siano la conseguenza di politiche nazionali e scelte governative statali. Così ad esempio quando certi ambientalisti si scagliano contro la globalizzazione per i danni ambientali che essa arrecherebbe in realtà non si rendono conto che le scelte riguardanti aria, acqua e emissioni nocive hanno una radice statale che è assolutamente nazionale. Lo stesso discorso vale poi per barriere tariffarie, ristrutturazione del mercato del lavoro, smantellamento del Welfare state. Lo stesso discorso vale, e la realtà dei fatti degli ultimi anni ce ne ha dato una drammatica conferma, per quanto riguarda quelle che, qualche anno fa, veniva definita “guerra permanente globale del capitale transnazionale”. Anche alcune conseguenze negative indotte dai processi di integrazione economica che portano alla nascita di blocchi economici regionali chiusi, come l’Unione Europea, sono spesso imputate erroneamente alla globlalizzazione.
La tendenza a prendersela con la globalizzazione per tutti i problemi che affliggono la vita moderna, così come imputare apologeticamente ad essa ogni cambiamento per riaffermarne il valore paradigmatico, si scontra dunque con una realtà ben più complessa all’interno della quale sono facilmente rintracciabile soggetti e forze materiali ben più concrete rispetto a ciò che si indica in genere con il termine globalizzazione.
Tutto ciò non fa che confermare una convinzione che personalmente ho avuto modo di esprimere in tempi non sospetti. A mio avviso globalisti e no global sono accomunati dalla condivisione di un analogo quadro analitico delle dinamiche internazionali, seppur ricondotto poi a posizioni politiche opposte. Global e no global hanno espresso in varie situazioni due approcci speculari che renderebbero, ad esempio, Negri e Hardt assolutamente complementari a iperglobalisti come Ohmae o Gray, ma anche a Giddens. Come già detto, ritengo che la globalizzazione sia una nuova forma di falsa coscienza dell’ideologia liberale e ritengo che così come nell’Ottocento numerosi ed autorevoli rappresentanti del socialismo utopistico ne furono in sostanza succubi, così in tempi più recenti diversi teorici no global (come i due citati) hanno accettato acriticamente buona parte delle categorie sulla globalizzazione diffuse in ambito liberale semplicemente per contrapporvisi.
Nel celebre libro Impero.Il nuovo ordine della globalizzazione, Toni Negri e Michael Hardt descrivevano la globalizzazione come un «processo definitivo e irreversibile», attraverso il quale il modo di produzione capitalistico si riforma per l’impossibilità di sopravvivere con le vecchie forme. In esso i processi di concentrazione e centralizzazione capitalistica, assumendo un carattere transnazionale – dal punto di vista della composizione della proprietà, della distribuzione territoriale dei processi produttivi, delle transazioni finanziarie – avrebbero minato in maniera irreversibile le strutture delle economie nazionali, fino ad annullare quindi gran parte delle funzioni proprie dello Stato-nazione. La globalizzazione cioè avrebbe limitato fortemente le possibilità dello Stato di incidere nelle leggi dell’economia attraverso la leva fiscale, le tariffe doganali, la programmazione della spesa pubblica con tutto quel che ciò comporta in termini di redistribuzione della ricchezza prodotta e tutela dei diritti sociali.
Tra le caratteristiche più peculiari di questo processo, ci sarebbe pertanto lo slittamento della sovranità degli Stati verso una nuova realtà definita «Impero» che sorgerebbe dal «crepuscolo della sovranità moderna»11. In essa il ruolo protagonistico sarebbe svolto dalle tecnocrazie degli organismi sovranazionali, che non solo avrebbero decretato il superamento del ruolo dello Stato-nazione, ma avrebbero addirittura determinato un’ attenuazione del ruolo egemonico degli USA. Sin dalla prefazione Negri e Hardt scrivono senza esitazioni: «Gli Stati Uniti non costituiscono più il centro di un progetto imperialista; e, in effetti, nessuno Stato-nazione può farlo oggi. L’imperialismo è finito. Nessuna nazione sarà oramai potenza mondiale come le nazioni dell’Europa moderna sono state».
Come già accennato tutto quel che è conseguito all’11 settembre, i conflitti in Afghanistan e Iraq, hanno completamente smentito e travolto queste analisi, al punto che già nel corso del 2002 sia Negri che Hardt hanno dovuto iniziare a revisionare le proprie teorie parlando di «colpi di coda imperialistici»
La convinzione con cui si è affermato che non sarebbe stato più possibile parlare di imperialismo, ma si sarebbe dovuto fare riferimento ad una nuova realtà, appunto quella imperiale, totalmente sganciata da un’origine e dimensione nazionale, si è inabissata nel breve volgere di due anni e oggi sempre più commentatori, anche non marxisti, parlano di imperialismo per descrivere la natura dei conflitti che insanguinano il pianeta.
La mia conclusione è che anche Negri e Hardt hanno subito fortemente l’egemonia della nuova vulgata del pensiero liberale perché oltre ad accettare in maniera neutra e quasi naturalistica l’idea della globalizzazione, così come questa è stata rappresentata, hanno accettato anche la presunta rappresentazione a-nazionale di organismi come il Fondo Monetario o la Banca Mondiale, accontentandosi della semplice facciata. La realtà, infatti, ha dimostrato che questi organismi non solo non hanno alcuna indipendenza dalle grandi potenze (USA, UE, Giappone) e quindi dalle loro economie nazionali, ma ne sono la loro diretta emanazione. Gli organismi sovranazionali infatti, non sono altro che camere di compensazione nelle quali si mediano gli interessi delle grandi potenze, all’interno delle quali il potere è direttamente proporzionale alla grandezza economico-militare di queste.
Così i tentativi di creare un regime internazionale per le imprese, il commercio e i mercati finanziari si è rivelato fino ad oggi del tutto inefficace proprio per le resistenze sia di governi che di gruppi d’interesse, gli strumenti in possesso di questi organismi sopranazionali per far rispettare le regole prescritte sono armi spuntate di fronte al mancato consenso degli stati. Ed in ogni caso estremamente rari sono gli interventi di censura degli organismi internazionali nei confronti delle infrazioni delle grandi potenze. Diverso è il caso dei paesi deboli, in via di sviluppo o in difficoltà economica che sia, ma in questo caso più che teorizzare sull’onnipotenza degli organismi sarebbe utile indagare sui veri mandanti che si celano dietro le sigle dei sicari.
E così come è illusoria l’idea degli organismi sovranazionali, altrettanto illusoria e l’idea per la quale è la natura transnazionale delle imprese – che avrebbe soppiantato gli interessi dell’economia nazionale – ad aver portato alla progressiva perdita di ruolo egli Stati nazionali, dato che, come ha ampiamente spiegato Gilpin, al di là della dislocazione produttiva, che comunque non è certo un fenomeno nuovo, la natura di queste è totalmente nazionale per quanto riguarda proprietà di mezzi di produzione e profitti, la direzione e le strategie perseguite, così come del resto i giri di affari, che per la più gran parte sono interni alle aree di origine di queste. Si dovrebbe anzi dire il contrario di quanto viene affermato, e cioè che proprio la dislocazione produttiva negli angoli più remoti del pianeta accresce il ruolo dello Stato-nazione, che si pone come il nume tutelare, politico-militare, di queste imprese, e che proprio gli interessi rappresentati dalle imprese transnazionali, non eliminano ma esaltano il ruolo imperialistico degli Stati-Nazione. Per quanto riguarda poi la finanziarizzazione dell’economia, questa ha accompagnato – non certo ostacolato – l’evoluzione del modo di produzione capitalistico in senso imperialistico, e questo (come abbiamo visto in apertura) a partire almeno dalla prima grande depressione economica tra il 1870 e il 1890, anzi la finanziarizzazione dell’economia è una delle condizioni essenziali perché possano determinarsi le tendenze di concentrazione monopolistica proprie dell’imperialismo.
In realtà i processi di mondializzazione economica non sono certo un’acquisizione recente, bensì una tendenza che ha attraversato in profondità tutta la fase di espansione legata alla rivoluzione industriale ed anche, in forme diverse, quelle precedenti. Già nel Manifesto Marx e Engels parlano del processo che da un’impronta cosmopolita alla produzione e al consumo mondiale, che priva l’industria della sua base nazionale, che porta questa a lavorare materie prime provenienti dalle parti più disparate del pianeta. Marx descrive con estrema linearità anche il determinarsi di nuovi bisogni dati dall’interdipendenza che si viene a creare nel nuovo mercato mondiale, interdipendenza che non riguarda solo le merci ma anche la produzione immateriale, la cultura, e così, «dalle letterature nazionali e locali si sviluppa una letteratura mondiale». Ma è soprattutto la valutazione relativa alla universalizzazione del modo di produzione e distribuzione borghese a mostrare in che misura ciò che viene spacciato come assoluta novità in realtà non lo sia.
«Col rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni rese infinitamente più agevoli, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni più barbare. I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con cui essa abbatte tutte le muraglie cinesi e con cui costringe alla capitolazione la più ostinata xenofobia dei barbari. Essa costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe a introdurre nei loro paesi la cosidetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza» 12.
Con ancora più precisione nel III volume del Capitale è indicato come il controllo delle colonie non solo quale sede ove esportare merci, ma come luogo in cui esportare capitali e sfruttare mano d’opera a basso costo sia una risposta delle potenze capitalistiche alla «caduta tendenziale del saggio di profitto». Già nel Capitale13 Marx segnala come la spartizione tra le potenze dei paesi sottosviluppati, sia una tendenza destinata ad accrescersi esponenzialmente e come questa stessa tendenza non risponda alle vecchie forme del colonialismo degli albori ma sia una funzione avanzatissima necessitata dalla ricerca di una nuova remunerazione del capitale indispensabile per compensare la sua caduta tendenziale nei paesi industrializzati.
Secondo la tesi sulla fine dello Stato, l’erosione delle sue funzioni, specie in economia, sarebbe la conseguenza di fattori molteplici: la necessità di tagliare la spesa pubblica – dunque le funzioni sociali dello Stato – per l’intensificarsi della competizione sui mercati; lo slittamento del potere reale dallo Stato alle imprese, dato che in mancanza di un intervento dei governi per aumentare la competitività (flessibilità del mercato del lavoro e abbattimento del costo del lavoro) queste semplicemente spostano la propria produzione in altri paesi o continenti, grazie alla avvenuta rivoluzione tecnologica, nei trasporti e nelle comunicazioni; la limitazione delle possibilità di intervento e scelta politica dei governi indotta dall’esigenza di attrarre capitali esteri e non far fuggire quelli nazionali; le ragioni di efficienza economica e competitività internazionale che porterebbe i governi nazionali a cercare un orientamento delle politiche verso le leggi di mercato e le compatibilità internazionali; i limiti imposti ai governi, nel perseguire una politica macroeconomica fiscale e monetaria, dall’integrazione globale dei mercati finanziari. In realtà l’intensificarsi della competitività economica internazionale, più che svuotare lo Stato di funzioni ne accrescerebbe l’attività perché anche le nazioni alfiere del liberismo, al di là delle proprie professioni di fede, sono ben poco disposte a lasciare il proprio destino totalmente in balia delle turbolenze internazionali e delle leggi di mercato.
Gianni Fresu
Bibliografia
Z. Barman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Editori Laterza, Bari, 1999
U. Beck, Che cos’è la globalizzazione: rischi e prospettive della società planetaria, Carocci Editore, Roma, 1999
Anthony Giddens, The consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990
F . Engels, Sul materialismo storico, Editori Riuniti, Roma
Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli Milano, 1992
A. Giddens, Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000
A.McGrew, Global Transformation: Politics, Economics and Cuture, cambridge, Polity Press, 1999
Culture e conflitti nella globalizzazione, a cura di Elisabetta Batini e Rodolfo Ragionieri. Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2002
D. Held, Democrazia e ordine globale, Asterios, Trieste, 1999
D. Held, Modelli di democrazia, Mulino Bologna, 1989
Karl Marx, Il Manifesto del partito comunista, Editori Laterza, Bari
Karl Marx, Il Capitale, Editori Riuniti, Roma, 1994
Karl Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma
Karl Marx, Friedrich Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma
«Ideazione», numero 5 settembre/ottobre 2001
Toni Negri, Michael Hardt, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione. Rizzoli, Milano, 2002.
Marco Revelli, La sinistra sociale, oltre la civiltà del lavoro, Bollati Boringhieri, Torino 1997
«Micromega», Globalizzazione, violenza e democrazia, n.4/2001
5 Carlo Jean afferma infatti che, nonostante l’erosione della loro sovranità, gli Stati restano i protagonisti principali anche nella fase della globalizzazione, e in ragione dei quali si interpreta la globalizzazione come una tendenza ciclica all’internazionalizzazione dei rapporti economici e politici che ha esempi fondamentali nella rivoluzione geomercantile del XVI secolo e nelle due rivoluzioni industriali del XVIII e XIX secolo
6 Memorabile la diretta RAI della riunione plenaria delle NU nella quale Jean si scagliò violentemente contro gli osservatori ONU, le pastoie burocratiche e i veti politici della vecchia Europa che impedivano la deliberazione immediata della guerra all’Iraq, colpevole a suo dire, senza alcuna ombra di dubbio, di detenere e occultare pericolosissime armi di distruzione di massa.
10 La seconda metà dell’Ottocento è contraddistinta da una serie di mutamenti talmente rapidi e profondi da avere determinato uno sviluppo delle forze produttive senza riscontri nella precedente storia dell’umanità. Tra il 1860 e il 1870 si raggiunge l’apogeo della libera concorrenza, con la crisi del 1873 inizia a delinearsi il sistema dei cartelli, quindi tra il 1890 e il 1903 (anno che a sua volta segna l’inizio di una nuova crisi) si registra un’ascesa del volume di affari e traffici che porta ad una sempre più forte concentrazione e centralizzazione dei capitali in ragione della quale l’organizzazione per cartelli diviene una base fondamentale di tutta la vita economica e non più un fenomeno transitorio legato alla congiuntura. Uno sviluppo impetuoso e rapidissimo con cui il capitalismo mondiale esce dalla grande depressione del 1873 che investe l’economia mondiale. Questa fase storica coincide infatti con la più grave crisi deflativa che avesse mai colpito il modo di produzione capitalistico, con il crollo dei mercati e dei profitti, con una stagnazione che per un certo periodo paralizza gli investimenti produttivi; una crisi all’interno della quale inizia a prendere corpo una radicale ristrutturazione che investe i rapporti tra capitale finanziario e industriale, le tecniche produttive utilizzate, le risorse energetiche impiegate. Dunque una serie di mutamenti “globali” incredibilmente radicali e rivoluzionari (non a caso si è parlato di Seconda rivoluzione industriale) per vastità e implicazioni internazionali.
11 «L’Impero si materializza sotto i nostri occhi. Nel corso degli ultimi decenni, con l’abolizione dei regimi coloniali e a ancor più velocemente dopo il crollo delle barriere sovietiche di fronte al mercato del mondo occidentale, abbiamo assistito ad una irresistibile e irreversibile mondializzazione economica degli scambi economici e culturali. Accanto al mercato mondiale ed ai circuiti mondiali di produzione sono sorti un ordine mondiale, una logica e una struttura nuova del potere – in breve, una nuova forma di sovranità. l’Impero è il soggetto politico che regola effettivamente gli scambi mondiali, il potere sovrano che governa il mondo». Toni Negri, Michael Hardt, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione. Rizzoli, Milano, 2002.