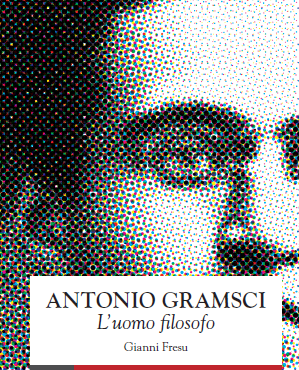Questione meridionale e questione sarda.
I temi dell’Autonomia e l’elaborazione dei comunisti.
Gianni Fresu
- Democrazia progressiva e autonomia.
Nella storia del movimento operaio italiano il Partito comunista, in alcune fasi della sua esistenza, ha saputo divenire un efficace strumento di partecipazione popolare grazie anche alla sua capacità di leggere le peculiarità storiche, economiche, sociali e culturali del nostro paese, costruendo su esse una prospettiva socialista che non fosse una riproduzione «pappagallesca» della teoria generale marxista. In questo senso la lezione leniniana sulla necessità di concentrarsi nello studio delle specificità di ogni singola «formazione economico-sociale», piuttosto che dedurre deterministicamente dalle leggi generali dell’economia le ragioni del socialismo e l’inevitabilità della rivoluzione, ha lasciato un solco profondo su cui si è innestata una elaborazione assai originale nella sua ricchezza e articolazione. Di questa ricchezza fa parte sicuramente lo sforzo per leggere nelle diversità dei rapporti di sfruttamento delle varie realtà italiane una trama unitaria, in ragione della quale, ad esempio, la questione meridionale andava intesa come grande questione nazionale, come crocevia attorno al quale ruotavano alcuni dei principali snodi degli assetti di dominio della società italiana.
All’interno di questa storia si inserisce anche la questione sarda e il tema dell’autonomismo nell’elaborazione dei comunisti. Essa nasce e si sviluppa con una prospettiva storicistica che ha quale dato di partenza due elementi nodali: 1) la condizione di oppressione secolare del popolo sardo nel corso delle diverse dominazioni, oppressione che ha trovato nei molteplici frangenti storici il fattivo sostegno delle stesse classi dirigenti sarde; 2) la marginalizzazione dei movimenti culturali e politici della Sardegna – da parte della letteratura storica e scientifica italiana – la sottovalutazione sistematica, sul piano politico, del diritto all’autodeterminazione culturale e politica, pur nel quadro unitario dello Stato italiano.
Il punto di approdo dell’autonomismo comunista si situa in una nuova concezione di sardismo inteso come terreno d’incontro tra gruppi intellettuali e masse sarde nella prospettiva del socialismo.
Per affrontare con sufficiente chiarezza questo tema è opportuna una precisazione preliminare sul contesto che gli fa da sfondo, più precisamente sulla situazione che caratterizza il PCI all’indomani della caduta del fascismo.
Con la «Svolta di Salerno» il PCI intraprendeva la strada dell’unità di tutte le forze antifasciste, comprese quelle stesse forze che avevano reso possibile e agevolato l’ascesa del fascismo (monarchia, esercito, liberali), rinviando la questione istituzionale su forma di Stato e forma di governo a liberazione avvenuta. Questa svolta, decisiva nel processo di liberazione del nazifascismo, impegnava i comunisti nella ricostruzione del quadro democratico senza alcuna ambiguità tattica o «doppiezza», si trattava di una scelta strategica destinata a mutare il ruolo dei comunisti nella storia d’Italia.
Ma come è stato ampiamente rilevato in sede storiografica, la «Svolta di Salerno», nel Sud e nelle Isole non si traduce immediatamente in una radicale riorganizzazione del modo di operare dei comunisti. Nel Mezzogiorno permangono limiti enormi sia tra le file dell’antifascismo, sia tra quelle del Partito comunista. Su questi limiti si è soffermato con attenzione Antonello Mattone:
Lo stesso dibattito interno sulle tematiche della svolta registra un dualismo di esperienze opposte tra le organizzazioni comuniste del Nord e quelle meridionali. Mentre nel Nord l’atteggiamento dei quadri è volto ad approfondire i contenuti della formula di democrazia progressiva e l’articolazione della nuova società antifascista attraverso i CLN, nel Mezzogiorno prevale la preoccupazione, frutto di un massimalismo generico e sovente anche messianico, di riaffermare i principi del comunismo e la purezza classista della linea politica. In definitiva il partito nel Meridione si pone al di fuori della linea indicata nella svolta; nel migliore dei casi essa viene interpretata come un espediente tattico necessario per la conquista del potere. Atteggiamenti e orientamenti settari sono assai diffusi nel partito, ne costituiscono quasi una doppia anima1.
Dall’8 settembre in poi si fa largo una realtà frammentata che a stento può essere identificata con una entità nazionale unitaria; non a caso Spriano, in proposito, ha parlato di tante Italie all’interno delle quali si diramano ulteriori sottoframmentazioni addirittura municipali. Tra esse proprio la Sardegna si distingue per il suo totale isolamento.
Se nel confronto tra le esperienze dei comunisti del Nord e quelli del Sud era possibile parlare di dualismo, rispetto alla Sardegna la differenza era ancora maggiore, perché l’isolamento geografico e l’assenza di contatti con la ricostituita direzione nazionale aveva lasciato fuori il PCI sardo dalla dialettica innescata dalla «Svolta di Salerno», che era stata recepita nell’isola come un «abile espediente tattico» ancora più che nel resto del Mezzogiorno.
In Sardegna il partito, che muove i suoi primi passi, si trova di fronte ad un compito immane di ricostruzione delle sue basi. Per andare oltre la condizione di silenzio e isolamento che i lavoratori sardi avevano dovuto subire per un intero ventennio, compito primario era di non ricadere nelle divisioni corporative che avevano limitato la sua forza egemonica nel passato, quando il movimento socialista rimase recintato nei bacini minerari limitandosi alle sole rivendicazioni degli interessi operai. Bisognava cioè unificare, sul piano politico generale, le rivendicazioni parziali della classe operaia, delle masse contadine e agro pastorali, in unico movimento popolare sardo capace di dettare l’agenda delle priorità della ricostruzione e l’orientamento del nuovo modello di sviluppo. I lavoratori dovevano liberarsi per sempre dallo sfruttamento secolare a cui erano stati sottoposti, il che significava liberarsi non solo dal dominio padronale straniero, ma contrastare da posizioni di forza anche quello sardo, per porsi essi stessi come nuova classe dirigente dell’Isola. Ma tra i comunisti sardi si afferma anche una tendenza storicamente radicata, seppur minoritaria, con ispirazione indipendentista.
Al primo Congresso regionale del partito, svoltosi a Iglesias il 13 e 14 marzo del 1944, una delegazione di comunisti galluresi si presentò chiedendo di essere accreditati all’assise in qualità di membri e delegati del Partito comunista sardo, del quale esisteva uno statuto e un programma. La richiesta venne respinta all’unanimità e si offrì al gruppo del PCS di partecipare ai lavori senza diritto di voto. Il gruppo del PCS si era sviluppato, fondamentalmente nella provincia di Sassari, nel caos organizzativo e politico proprio del periodo che va dal dicembre del 1943 al giugno 442.
Il PCS nel suo manifesto si richiamava all’ideale della Repubblica federativa sovietica della metà degli anni venti e indicava come obiettivo programmatico la costituzione di una autonoma Repubblica sarda degli operai e dei contadini. Nel solco tracciato dal Krestintern del 1925 il PCS riproponeva l’alleanza strategica con il PSd’A e intendeva federarsi al Comintern (in realtà già sciolto per l’alleanza contro il nazifascismo) autonomamente dal PCI. Il PCS, pur ricollegandosi alla linea del PCI, «riteneva che la Sardegna fosse una realtà a sé stante e che male sopportasse l’imposizione di forme istituzionali e di organismi politici propri del continente; individuava nella politica fiscale dello Stato la causa dell’arretratezza dell’isola e criticava l’incapacità del liberalismo, del fascismo, ma anche del socialismo, di dare alla Sardegna un assetto politico e istituzionale consono alle sue peculiarità. Solo al sardismo si riconosceva di aver compiuto uno sforzo in tale direzione, peraltro inadeguato per carenze organizzative e programmatiche»3.
L’emergere, ed eventualmente il prevalere, di posizioni isolazioniste, come quelle del PCS, tra i comunisti sardi avrebbe potuto significare l’autoestromissione della Sardegna dal profondo processo di rinnovamento democratico di cui la Resistenza antifascista era protagonista, ciò indusse tutto il gruppo dirigente sardo del PCI a combattere con durezza le posizioni separatiste, così come i residui di settarismo che ancora galleggiavano tra i suoi quadri e militanti, il partito doveva operare a stretto contatto con le condizioni materiali di esistenza delle classi subalterne, la sua composizione sociale e la sua direzione politica dovevano sorgere naturalmente da esse. Il «Partito nuovo» non poteva più essere l’organizzazione degli avvocati e dei professori, doveva realmente divenire il partito dei lavoratori.
2. Da Lione alla Questione meridionale, l’alleanza operai-contadini.
Costruire in Sardegna un Partito di lavoratori di massa significava affrontare di petto la questione contadina ed investire tutte le proprie energie nella costruzione di un movimento avanzato tra le masse dei contadini senza terra e i braccianti per sottrarli all’influenza e alla direzione della Chiesa e dei movimenti più conservatori.
In Sardegna favorire la nascita del movimento cooperativo tra contadini e pastori era l’unico modo per superare la dispersione sociale e territoriale di quelle realtà e anche il modo per dare un radicamento di massa al partito. Bisognava lavorare nel movimento contadino fino a svilupparlo e a farne una forza sociale capace di incidere sugli equilibri politico-sociali dell’isola.
L’emergere di una questione meridionale, e al suo interno di una specifica questione sarda, erano scaturite dal tentativo di tradurre in italiano la teoria politica di Lenin, a partire dal tema dei temi, per quel tempo: l’alleanza operai-contadini, che si era rivelata determinante per la vittoria della rivoluzione d’ottobre. Le riflessioni delle Tesi di Lione e la Questione meridionale, rispondevano esattamente a questa esigenza nel tentativo di disarticolare il blocco sociale reazionario che dominava l’Italia dall’Unità all’avvento del fascismo.
Secondo le Tesi di Lione, l’elemento predominante della società italiana era dato da una particolare forma di capitalismo nel quale convivevano un industrialismo ancora debole ed incapace di assorbire la maggioranza della popolazione e un’agricoltura che costituiva la base economica del paese, segnata dalla netta prevalenza in essa di ceti poveri (bracciantato agricolo) molto prossimi alle condizioni del proletariato e perciò sensibili alla sua influenza.
Tra le due classi dominanti – industriali e agrari – si poneva quale elemento di raccordo una media e piccola borghesia urbana abbastanza estesa. La debolezza del modo di produzione in Italia – che non poteva disporre di materie prime – spingeva gli industriali a varie forme di compromesso economico con i grandi latifondisti agrari che si basavano su «una solidarietà di interessi» tra ceti di privilegiati a detrimento degli interessi generali della produzione e della maggioranza della popolazione. Anche il processo risorgimentale era espressione di questa debolezza, perché la costruzione dello Stato nazionale era stata possibile grazie allo sfruttamento di particolari fattori di politica internazionale e il suo consolidamento aveva necessitato quel compromesso sociale che ha reso inoperante in Italia la lotta economica tra industriali e agrari, la rotazione di gruppi dirigenti, tipici di altri paesi capitalistici. Secondo Gramsci, questo compromesso a tutela di uno «sfruttamento parassitario» delle «classi dominanti» aveva determinato una polarizzazione tra l’accumulo di immense ricchezze in ristretti gruppi sociali e la povertà estrema del resto della popolazione; aveva comportato il deficit del bilancio, l’arresto dello sviluppo economico in intere aree del paese (come il Mezzogiorno), ostacolando una modernizzazione del sistema economico nazionale armonica e calibrata con le caratteristiche del paese.
Il compromesso tra industriali e agrari attribuiva alle masse lavoratrici del Mezzogiorno la stessa posizione delle popolazioni coloniali; per esse il Nord industrializzato diveniva come la metropoli capitalistica per la colonia; le classi dirigenti del sud (grandi proprietari e media borghesia) svolgevano la stessa funzione delle categorie sociali delle colonie che si alleano con i coloni per mantenere la massa del popolo soggetta al proprio sfruttamento. Tuttavia nella prospettiva storica questo sistema di compromesso si è rivelato inefficace perché si è trasformato in un ostacolo allo sviluppo tanto dell’economia industriale, quanto di quella agraria; ciò ha determinato in diverse fasi livelli molto acuti di lotta tra le classi e quindi la pressione sempre più forte ed autoritaria dello Stato sulle masse. In Italia il processo d’unificazione nazionale non si è realizzato sulla base di un rapporto d’uguaglianza, ma attraverso una relazione squilibrata all’interno della quale l’arricchimento e l’incremento industriale del Nord dipendono strettamente dal crescente impoverimento del Mezzogiorno. Nella Questione meridionale, premessa fondamentale alle riflessioni sul Risorgimento nei Quaderni, Gramsci definisce il Mezzogiorno come una grande disgregazione sociale, all’interno della quale i contadini non hanno alcuna coesione tra di loro. Le masse contadine, che costituiscono la maggioranza della popolazione meridionale, non riuscendo a dare «espressione centralizzata» alle proprie aspirazioni, materializzano il loro perenne fermento attraverso uno stato di ribellismo endemico privo di prospettive. Al di sopra di queste masse si struttura l’assetto di dominio del blocco agrario che, attraverso le sue «proporzioni definite», riesce a mantenere le masse contadine permanentemente nella loro condizione «amorfa e disgregata» e ad evitare qualsiasi forma di centralizzazione a quello stato di perenne fermento. L’esito del Risorgimento entro un equilibrio moderato non ha fatto altro che innestare su questa secolare struttura di potere il dominio del capitalismo settentrionale saldatosi, dopo l’unità, a quello della borghesia agraria del Sud in un nuovo blocco storico la cui chiave di volta risiedeva nella funzione degli intellettuali. Gramsci dunque nel porre la questione contadina come questione meridionale rappresenta quest’ultima come questione nazionale, all’interno della quale si situa con le sue specificità geografiche storiche e culturali, una questione sarda.
- La dialettica con la DC alla Costituente e l’emergere della questione autonomistica.
Tuttavia nel PCI del dopoguerra per giungere nuovamente a questa consapevolezza, e ricomporre il filo interrotto con l’elaborazione della metà degli anni 20’, occorreranno anni e un lungo processo di lotte e riflessioni. Bisogna infatti ricordare che nel dibattito dell’Assemblea costituente la posizione del PCI era più orientata verso il municipalismo, che rivendicava la continuità storica con la tradizione dei Comuni e intendeva mettere a valore il patrimonio delle «cento città»; era una posizione che si basava sulla necessità di un forte decentramento amministrativo a comuni e province ma sul rispetto assoluto dell’unità politico territoriale del paese e quindi della potestà legislativa centrale. Il PCI interpretava al tempo la funzione delle regioni ordinarie come enti autarchici e organi di largo decentramento amministrativo. Secondo quella posizione, la creazione di una struttura federale o a forte regionalismo avrebbe invece portato al consolidarsi dei blocchi di potere che dominavano il Mezzogiorno acuendo la frattura tra Nord e Sud, ma soprattutto avrebbe impedito l’attuazione organica ed omogenea delle riforme a carattere generale, le cosiddette «riforme di struttura». Dunque solo per Sardegna e Sicilia si prevedeva un ipotesi di specialità nell’attribuzione di competenze, facendo però salva la capacità impositiva e d’intervento dello Stato, che era ritenuto il solo organo capace di reperire le risorse e approntare gli strumenti per le profonde trasformazioni economiche e sociali che le due Isole necessitavano.
Sul terreno dell’articolazione dei poteri e della struttura regionale il PCI alla Costituente esprimeva ancora una posizione molto arretrata seppur imposta da un contesto assai complesso: si riconosceva che l’istituzione delle regioni avrebbe avvicinato il popolo alle amministrazioni attraverso il decentramento, ma si sottolineava altresì che qualora alle regioni fossero stati attribuiti poteri esorbitanti da quelli della semplice amministrazione, fino a determinare una potestà legislativa esclusiva ed anche concorrente, la posizione del PCI sarebbe stata contraria.
Una tale accelerazione, più che la democratizzazione di ampi settori e rami della vita politica del paese, avrebbe favorito, secondo i comunisti, il frazionamento del potere legislativo e la disgregazione dell’unità organica del paese. La preoccupazione del PCI era che con la frammentazione politica del paese importanti riforme socio-economiche, come ad esempio una profonda riforma agraria, o la nazionalizzazione di importanti settori dell’economia (si pensi alla produzione e distribuzione dell’energia elettrica), avrebbero trovato mille ostacoli nell’applicazione. In questo modo si sarebbe stabilito nel corpo della democrazia italiana un sistema per compartimenti stagni. Sempre secondo questo ordine di ragionamenti il PCI si espresse contro il principio della autonomia della Magistratura, palesando il rischio che la magistratura divenisse un corpo a sé stante regolato da modalità di autogoverno proprie.
Su questa posizione sicuramente aveva influito il timore che la Magistratura (come più in generale la burocrazia e le forze armate) ereditata dal Ventennio potesse divenire un autonomo capace di condizionare negativamente il processo democratico. Le paure espresse in tal senso erano le prime avvisaglie di un clima nuovo che andava mutando nel paese proprio in quei mesi. Il 31 maggio del 1947, con l’estromissione di comunisti e socialisti dal governo, «si archiviava definitivamente la realtà politica uscita dalla resistenza; cominciava una dura stagione della Repubblica»4.
Sull’articolazione dei poteri le posizioni dei comunisti mutano profondamente nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta e nell’orientare questo mutamento l’azione e l’elaborazione di alcuni comunisti sardi è determinante. Inizialmente però, all’indomani della caduta del fascismo, sul tema dell’autonomia anche il PCI sardo ha scontato un ritardo notevole e ha commesso diversi errori. Le cause di tale ritardo e dell’iniziale propensione antiautonomista dei comunisti sardi erano molteplici e ramificate. Tra queste bisognava considerare anzitutto l’origine dei dirigenti che ripresero l’attività nel 1943: molti di essi provenivano dall’attività clandestina, erano quadri che avevano oramai metabolizzato una concezione settaria dell’agire politico; altri ancora provenivano dal Partito socialista che tradizionalmente era più attento alle questioni delle zone urbane ed industriali piuttosto che alle questioni contadine. Oltre a ciò c’era la contrapposizione alle frange del movimento indipendentista che aveva contribuito a rendere sospettosi, se non proprio ostili, i comunisti sardi verso ogni discorso autonomistico. Per lungo tempo la maggioranza dei comunisti sardi ha considerato fuorviante e interclassista la parola d’ordine dell’unità di tutti i sardi per l’autonomia.
Da tutto ciò derivavano l’atteggiamento incerto e attendista e i ritardi nella piattaforma politica, che si palesarono al primo Consiglio Nazionale del PCI tenutosi a Roma nell’aprile del 1945 dove la delegazione sarda era composta da Renzo Laconi, Antonio Dore e quindi Giovanni Lay che in proposito ha scritto:
In quell’occasione io fui aspramente criticato da Togliatti perché feci un intervento che suonava pressappoco così: “i contadini e i pastori sardi non sanno che farsene di un’autonomia regionale guidata dai proprietari terrieri e dai nemici della Sardegna che sono presenti anche nell’Isola. Noi dobbiamo batterci per un’autonomia che sia strumento di progresso sociale ed economico, che liberi il popolo sardo dalla miseria e dallo sfruttamento, che salvi le miniere, che valorizzi le risorse umane ed economiche della Sardegna”.
Nelle conclusioni dei lavori del Consiglio nazionale Togliatti disse: “Se il compagno Gramsci fosse stato qui presente e avesse udito un comunista sardo, per giunta dirigente del Partito in Sardegna, sostenere che i contadini sardi e i pastori non sanno che farsene dell’autonomia, certamente ne sarebbe rimasto molto sorpreso”. (…) Togliatti criticò i dirigenti del Partito in Sardegna non tanto per quello che era stato detto in quella sede, ma per il fatto di non essere stati ancora capaci di impegnare le masse popolari sarde nella battaglia per “togliere la bandiera dell’autonomia” dalle mani di quelli che pensavano di fare dell’autonomia regionale la loro cittadella per la difesa dei loro interessi di classe, e farla passare nelle mani della classe operaia5.
Anche se non solo in ragione di questo fatto, la rivendicazione autonomista viene ad essere assimilata solo dopo il superamento del “pericolo” rappresentato dalla prospettiva del PCS.
Sul versante istituzionale poi, la Consulta tardò enormemente ad elaborare un proprio progetto, mentre già dal maggio del 1946 il Governo aveva promulgato lo Statuto speciale siciliano. Come è noto Lussu, storico leader del sardismo, preoccupato per i ritardi e per l’irrigidimento della DC sulle questioni autonomistiche, si adoperò presso i rappresentanti della Consulta per ottenere l’estensione dello Statuto siciliano alla Sardegna ottenendone un rifiuto. Anche la delegazione del PCI si unì nel rivendicare alla Consulta il compito di scrivere il proprio Statuto, con il risultato di ritardare fino alla fine del gennaio 1948 la promulgazione di uno Statuto dai contenuti autonomistici decisamente più blandi di quello siciliano.
4. Renzo Laconi e la svolta autonomista.
Il II Congresso regionale del PCI, tenutosi a Cagliari nel maggio del 45, non era stato in grado di realizzare sino in fondo la svolta da tutti attesa; a pagarne le spese fu il Segretario regionale Antonio Dore sostituito da Velio Spano, il più autorevole ed esperto tra i comunisti sardi. Il tutto avvenne nella conferenza regionale del Partito tenutasi nell’aprile 1947 a Cagliari e presieduta da Palmiro Togliatti, che aveva sferzato duramente i ritardi del Partito sardo rispetto al resto d’Italia e polemizzato contro le resistenze alla linea nazionalmente definita. Le contraddizioni in cui si dibattevano i comunisti sardi erano per Togliatti dovute al loro modo di ricondurre le questioni dell’autonomia direttamente alle contraddizioni di classe, senza comprenderne la valenza democratica. Afferrare il significato democratico e non di classe della questione autonomistica significava renderla battaglia unitaria di tutte le forze democratiche, bandiera dell’intero popolo sardo. Per Togliatti recintare settariamente la battaglia autonomistica alle sole classi subalterne ne avrebbe depotenziato la spinta, senza peraltro agevolare il compito di conquista egemonica dell’articolazione sociale da parte dei lavoratori. Le classi subalterne dovevano divenire classe dirigente nell’allargamento progressivo degli spazi di democrazia sociale, economica, politica, e anche le lotte per l’autonomia costituivano un banco di prova, una verifica della maturità dei comunisti.
L’obiettivo posto da Togliatti era costruire il grande partito delle masse sarde. Dunque, nonostante la dialettica della Costituente avesse spinto il PCI su posizioni piuttosto rigide, fu proprio Togliatti a sollecitare una svolta autonomistica tra i comunisti sardi. Di questa svolta diviene protagonista assoluto un giovane dirigente, Renzo Laconi, destinato ad essere l’interprete più originale della concezione togliattiana sul «Partito nuovo» in Sardegna.
Renzo Laconi, oltre ad essere stato uno dei più autorevoli dirigenti comunisti del partito in Sardegna, è stato stretto collaboratore di Togliatti. A soli trenta anni è eletto nell’Assemblea costituente e, nonostante la sua giovane età, diviene membro della Commissione dei settantacinque, incaricata di redigere il disegno costituzionale; partecipa alla Commissione ristretta dei diciotto, quando Togliatti è impossibilitato a prendervi parte; è il relatore del gruppo comunista sul disegno costituzionale e in tale vece apre gli interventi dei comunisti nella discussione generale dell’Assemblea.
Laconi pose costantemente la questione autonomistica al centro della sua azione di costituente. In tal senso intervenne all’Assemblea Costituente, richiamando con urgenza il licenziamento dello Statuto autonomistico della Sardegna, già approvato il 29 aprile del 1947 dalla Consulta regionale e quindi presentato dall’Alto Commissario al Governo De Gasperi. La situazione economica e sociale della Sardegna richiedeva infatti un intervento rapido, perché se era vero che le condizioni di arretratezza dell’Isola avevano radici secolari, lo era altrettanto che il ventennio fascista e la guerra ne avevano aggravato la patologia.
In quest’importante intervento Laconi rivendicava al PCI l’eredità di un processo di emancipazione che affondava le sue radici nelle lotte antifeudali e più in generale nelle aspirazioni storiche del popolo sardo. Le ragioni dell’autonomismo sardo non venivano per Laconi solo da motivi storici o geografici ma dal modo stesso attraverso cui si è sviluppato il rapporto della Sardegna con il Piemonte prima e l’Italia poi. L’annessione della Sardegna era infatti il frutto di un atto diplomatico militare e non del processo di rinnovamento sociale e unificazione economica che ha contraddistinto il Risorgimento. In tal senso Laconi si richiamava alle secolari lotte di contadini e pastori contro la signoria feudale per gli usi civici della terra, riaffiorati con la legge delle chiudende del 1820 e l’editto istitutivo della proprietà perfetta, che aboliva il feudalesimo nell’Isola, del 1836. Anche quelle riforme, nate con l’intento di giungere alla modernizzazione economica dell’isola, non mutarono la natura dello sfruttamento coloniale delle risorse sarde da parte prima del capitalismo mercantile e poi di quello industriale. Da ciò le contraddizioni mai sanate tra le esigenze di progresso e una realtà fatta di isolamento e miseria, dove l’unico rifugio possibile era nella tradizione dei modi di vita, lavoro e relazione sociale.
E da questa contraddizione scaturisce, ancora, sulle labbra del pastore e del contadino isolano il grido che guidava i padri nelle lotte contro il Piemonte: torrare a su connottu; sos muros a terra, grido che non risponde certo ad una chiara prospettiva politica, che non indica, forse, esattamente la strada di rinnovamento dell’economia isolana, ma esprime la ribellione dell’uomo semplice contro uno stato di cose ingiusto e il rimpianto dei tempi passati, migliori forse del presente6.
Per queste ragioni qualsiasi movimento culturale e politico degno di questo nome, sorto in Sardegna, non poteva che assumere carattere regionale e autonomistico. Ciò trovava puntuale riscontro nella letteratura sarda, nelle lotte, nella propaganda, nella politica isolana.
Riassunta venticinque anni fa in un programma politico della corrente che faceva capo al Partito sardo d’azione, condivisa dalle componenti più avanzate del movimento socialista, la rivendicazione autonomistica è oggi patrimonio di tutti i partiti dell’Isola e costituisce la comune rivendicazione di tutti i sardi7.
Era dal riconoscimento di questa storia che il diritto di cittadinanza dei sardi, nello Stato italiano rinnovato, andava ricostruito su basi politiche nuove.
In Sardegna la consapevolezza sul valore democratico della battaglia autonomista era anche il risultato delle esperienze di lotta popolare (dai contadini di Bonorva, ai pastori, ai minatori del Sulcis, ai pescatori degli stagni). Questo perché le condizioni di arretratezza e miseria della Sardegna avevano sicuramente un’origine riconducibile ai rapporti sociali di produzione esistenti, ma chiamavano fortemente in causa la struttura centralizzata di una amministrazione burocratica, sempre più sclerotica e inefficiente, l’inadeguatezza della struttura giuridica e politica del paese. Per vincere i mali della Sardegna bisognava farla uscire dalla condizione di passività a cui era stata condannata nei secoli dai diversi dominatori, farla divenire soggetto attivo del suo sviluppo e della sua emancipazione. Ciò inevitabilmente doveva passare da un profondo rinnovamento democratico della struttura amministrativa e la creazione di una specifica legislazione adatta alle esigenze della Sardegna, vale a dire dall’attuazione dell’autonomia regionale.
- Autonomia, programmazione economica. La stagione delle lotte per la Rinascita.
Proprio sul tema dell’autonomia regionale in quegli anni si era venuta a determinare una inversione di posizioni tra DC e PCI: la prima sostiene inizialmente un’ipotesi riformatrice di forte decentramento regionale e poi però ritarda enormemente la creazione delle regioni ordinarie; il PCI invece, assume in un primo momento un atteggiamento ostile verso ogni ipotesi di ridimensionamento delle prerogative dello Stato centrale, per poi fare propria la rivendicazione regionale come riforma imprescindibile.
Nonostante questa dialettica, sul piano regionale si era invece registrata una convergenza sull’esigenza della programmazione economica regionale che aveva trovato traduzione nel piano quinquennale, elaborato tra marzo e febbraio 1947 e presentato dall’Alto Commissario Pietro Pinna. Il piano raccoglieva le istanze provenienti dai territori e dalle comunità locali e chiedeva al Governo lo stanziamento di ottantacinque miliardi di lire per le opere infrastrutturali viarie, portuali, ferroviarie, per la realizzazione di sistemi fognari e idrici, per una elettrificazione dell’Isola che ne agevolasse l’industrializzazione. In tale direzione era prevista l’istituzione del Banco di Sardegna, la creazione di un unico ente sardo per l’energia elettrica e la acquisizione pubblica del sistema ferroviario complementare.
Nonostante questa convergenza a livello regionale l’approvazione dello Statuto e del Piano Pinna, trovarono un ostacolo insormontabile nelle scelte del governo nazionale, che nell’estate del 1947 respinse il Piano per mancanza di copertura finanziaria. Tutto questo aveva portato il PCI ad organizzare la mobilitazione per l’autonomia, con una grande manifestazione popolare, alla quale aveva aderito anche la DC, e il convegno regionale dei partiti autonomisti del settembre del 1947, nel quale era stata lanciata la parola d’ordine della lotta unitaria dei partiti sardi per l’autonomia. Come è noto lo Statuto venne approvato, seppur ampiamente modificato e profondamente ridimensionato, rispetto a quello approvato dalla Consulta, solo il 31 gennaio del 1948, cioè allo scadere del mandato dell’Assemblea Costituente.
La delusione suscitata da questo esito fece scaturire un inasprimento della dialettica politica tra DC e PCI. Ne è un esempio l’articolo al vetriolo scritto da Velio Spano per «Il Lavoratore» intitolato Regionalismo democristiano8. In esso Spano riportava l’ultima discussione in seno alla Costituente e accusava la DC di aver sacrificato le ragioni autonomistiche della Sardegna sull’altare dei suoi piccoli interessi. Gli ostacoli frapposti e il risultato conseguito chiarivano per Spano che il partito di De Gasperi considerava «La Sardegna come una riserva possibile della reazione» ed era mosso dalla volontà di «isolarla da ogni influenza democratica». Al contrario si sarebbero dovuti riconoscere «i torti secolari che sono stati fatti alla Sardegna» risarcendo il popolo sardo e mostrando fiducia nei suoi confronti. A questo articolo ne seguiva un altro, pubblicato il 7 febbraio su «Il Lavoratore», nel quale Spano parlava di «cretinismo paternalistico savoiardo» riemergente e polemizzava duramente con la tesi secondo cui lo Statuto approvato era persino troppo avanzato per i sardi.
[tale tesi, scrive Spano] mette a nudo le vere intenzioni di quei parrucconi di costituzionalisti continentali e di politicanti sardi che avevano cercato di nascondere la loro pelle di anti-autonomisti sotto le vesti del regionalismo. Ecco il punto! Che cos’era dunque il regionalismo di lorsignori?
Noi concepivamo e concepiamo lo Statuto come un mezzo che aiuti il popolo sardo a camminare, a camminare svelto. Quei signori concepiscono lo Statuto come un osso gettato a un cane per evitare che ringhi. Noi siamo autonomisti, siamo sardisti, quei signori sono regionalisti. E il loro regionalismo mostra oggi apertamente la sua doppia faccia sociale e politica: la faccia sociale conservatrice della vecchia e fallita classe dominante la quale, stabilendo una eguaglianza giuridica formale tra le regioni italiane, vuole in realtà sancirne la disuguaglianza profonda e perpetuarne lo sfruttamento coloniale del capitalismo settentrionale sulle masse rurali del Mezzogiorno e delle Isole9.
È a partire da questa grande delusione che prende le mosse la stagione delle lotte autonomistiche per il Piano di Rinascita. Nel 1949 Velio Spano, segretario e massimo dirigente sardo del PCI, chiese ed ottenne l’autorizzazione ad assentarsi dalla Sardegna per partecipare, insieme alla delegazione del Comitato Centrale, alle celebrazioni per la proclamazione della Repubblica popolare cinese che iniziarono il primo ottobre 1949. Nel periodo di assenza di Spano la segreteria regionale, della quale facevano parte Laconi e Lay, fu allargata con l’ingresso di Luigi Pirastu (allora Capogruppo in Consiglio Regionale) e la sua direzione venne affidata temporaneamente al partigiano emiliano Luigi Orlandi, mandato da Roma per aiutare nella costruzione del partito e per contribuire a riassorbire le tensioni accumulatesi.
Proprio in questa fase Laconi propose di incentrare l’iniziativa del PCI attorno alla rivendicazione del «Piano del Lavoro». L’idea avanzata da Laconi era che si facesse leva sull’articolo 13 dello Statuto autonomistico e sulle previsioni del piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna finanziato dallo Stato. Attorno a questa rivendicazione bisognava costruire un movimento di lotta di massa, unitario di tutte le forze democratiche, capace di coinvolgere contadini, pastori e tutti i lavoratori della Sardegna. Nell’intento di Laconi infatti il Piano per il Lavoro avrebbe dovuto essere il terreno concreto per la realizzazione dell’alleanza operai-contadini attraverso una profonda e radicale riforma agraria e un intervento infrastrutturale per l’uso razionale delle risorse idriche dell’isola. A tal fine venne convocato un primo congresso regionale promosso dalle camere del lavoro che si concluse con l’invito ai lavoratori, alle forze politiche e quelle culturali per l’organizzazione di un «Congresso del Popolo Sardo».
Quattro mesi dopo il Convegno organizzato dalle Camere del Lavoro di Cagliari, Sassari e Nuoro si teneva al Teatro Massimo di Cagliari il Congresso del popolo sardo, nel quale il tema di un Piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna era affrontato come prima battaglia attuativa della Costituzione e dello Statuto. L’obiettivo era fare del Piano la bandiera autonomistica di tutto il popolo sardo, senza distinzioni ideologiche o di partito. Laconi era il relatore introduttivo.
Sul piano storico l’assenza di capitali da investire nella modernizzazione sociale ed economica era riconducibile al mancato formarsi in Sardegna di una classe borghese degna di questo nome. Le classi possidenti sarde, come quelle meridionali, avevano vissuto di rendita parassitaria spendendo quella rendita senza alcuna ricaduta produttiva e senza alimentare quote significative di risparmio. Da ciò l’evidente contrasto tra l’opulenza della nobiltà inurbata e la decadenza sia delle campagne che delle città. Una condizione che anche Gramsci aveva fotografato, seppur con differenze significative, nelle note di Americanismo e fordismo in rapporto alla struttura economico-sociale del napoletano10.
Neanche i tentativi tesi a stimolare l’iniziativa economica, attraverso la formazione di un capitale originario, come era avvenuto con la Legge delle chiudende o con la Legge Cocco Ortu, riuscirono a trasformare la natura della borghesia della Sardegna e con essa la sua società. L’unificazione totale del 1848 – che sopprimeva gli antichi istituti autonomistici del Regno di Sardegna uniformando l’Isola al resto dei domini piemontesi – veniva dopo una serie di provvedimenti legislativi tesi a integrare anche economicamente la Sardegna agli Stati continentali. In tal senso la legge delle chiudende del 20 e quella sulla proprietà perfetta del 36 erano finalizzate a distruggere il sistema feudale suscitando il formarsi una borghesia imprenditoriale di tipo europeo. Allo stesso scopo tendevano la liquidazione dei beni e dei diritti della Corona sulle risorse industriali e la creazione ad opera di Cavour di una Banca locale per mettere a frutto il risparmio. Da questo punto di vista l’unificazione totale e l’abolizione dell’autonomia rispondevano al tentativo di aprire la Sardegna ai capitali stranieri e inserire l’Isola nei flussi commerciali del tempo. Tuttavia questo tentativo era fallito perché la borghesia sarda non era riuscita a reggere il confronto con le profonde trasformazioni in atto. In una simile situazione non c’è stata alcuna modernizzazione ma solo l’accaparramento delle risorse da parte della borghesia forestiera che ha iniziato a commerciare i prodotti della Sardegna portando fuori da essa i profitti. Da questa debolezza delle sue classi dirigenti si originavano molti dei guasti che angustiavano la Sardegna sul piano sociale ed economico. Ne da conto lo stesso Antonio Gramsci in un articolo del 1919, falcidiato dalla censura, intitolato I dolori della Sardegna.
Perché deve essere proibito all’ «Avanti!» ricordare che a Torino hanno la sede i consigli di amministrazione delle ferrovie sarde e di qualche società mineraria sarda? (…) Perché non si può ricordare che i minatori sardi sono pagati con salari da fame, mentre gli azionisti torinesi impugnano i loro portafogli con dividendi cristallizzati con il sangue dei minatori sardi, che spesso si riducono a mangiare le radici per non morire di fame? Perché deve essere proibito ricordare che due terzi degli abitanti della Sardegna vanno scalzi d’inverno e d’estate, perché il prezzo delle pelli è portato alle altezze proibitive dai dazi dei protettori che arricchiscono gli industriali torinesi del cuoio, uno dei quali è presidente della Camera di Commercio di Torino? Perché è proibito ricordare che nello Stato italiano, la Sardegna dei contadini, dei pastori e degli artigiani è trattata peggio della colonia eritrea, in quanto lo Stato «spende» per l’Eritrea, mentre sfrutta la Sardegna, prelevandovi un tributo imperiale?11
Anche nel secondo dopoguerra poi, la riforma agraria Segni non aveva mutato la sostanza dei rapporti sociali nelle campagne e l’opera di bonifica procedeva con una lentezza e disorganicità che impedivano qualsiasi modernizzazione e resa produttiva dell’agricoltura sarda. La soluzione della questione agraria era la strada per far fronte al problema dello scarso popolamento della Sardegna. In tal senso il Piano sarebbe dovuto intervenire per porre fine alla concentrazione della proprietà fondiaria e alla contemporanea polverizzazione nella sua distribuzione. Bisognava costruire aziende agrarie moderne su superfici estese e con strutture sociali progredite avendo come prospettiva la riorganizzazione economica delle comunità. A questa trasformazione doveva concorrere l’opera di popolamento delle campagne attraverso la creazione di reti stradali, borgate rurali e case coloniche dando nuove possibilità di lavoro. Questo, insieme all’opera di bonifica che uno specifico ente regionale avrebbe dovuto assumere come attività sua propria, per far fronte ad una situazione non riscontrabile in nessuna altra regione d’Italia.
Senza entrare nel dettaglio della proposta avanzata basti qui richiamare alle articolazioni di intervento che si prospettavano per il piano: dalla riorganizzazione dell’agricoltura e dell’allevamento a un nuovo piano di raccolta e distribuzione delle risorse idriche, da un piano energetico regionale alla riorganizzazione del credito regionale, dalla modernizzazione della trasformazione industriale al rilancio della struttura commerciale. La proposta di Piano doveva seguire una filosofia il più possibile integrata tra i settori d’investimento pubblico, avrebbe dovuto svolgere, verso l’economia e la società, quella funzione centralizzazione delle risorse per un comune obiettivo di sviluppo che era mancata in passato.
La battaglia per il Piano di rinascita durò tredici anni e andò costituendo in suo favore un grande movimento popolare che diede un contenuto nuovo ed avanzato alla vecchia rivendicazione autonomistica, evitando al contempo l’idea tradizionale del meridionalismo che concepiva lo sviluppo come un’opera unilaterale dello Stato centrale, attuata in via amministrativa dalle burocrazie regionali . L’idea del Piano di Rinascita si basava sull’esigenza di sfruttare a pieno le risorse della Regione, intesa non più come organo passivo di politiche elaborate a Roma, ma ente propositivo e protagonista capace di avanzare e realizzare politiche di programmazione economica e sviluppo. Una programmazione dal basso, capace di coinvolgere i cittadini e gli stessi Enti Locali.
In Sardegna la lotta autonomista per la programmazione democratica conferisce un contenuto nuovo alla vecchia ideologia autonomistica, rimasta concettualmente e politicamente separatista e sostanzialmente autarchica. L’idea di programmazione democratica legata al Piano di rinascita si basava sul rifiuto delle vecchie concezioni autonomiste secondo cui il Sud e le Isole lasciate libere di svilupparsi per conto proprio, senza i condizionamenti nazionali, avrebbero risolto da sole i propri problemi. Questa impostazione era ideologicamente liberista e si basava sulla rivendicazione per i punti franchi e conto i protezionismi doganali.
Ma la lotta per la rinascita rifiutava anche l’impostazione centralistica, burocratica e assistenziale del vecchio meridionalismo, secondo la quale lo sviluppo del Mezzogiorno poteva realizzarsi attraverso leggi speciali decise e finanziate da Roma e tese a interventi infrastrutturali. Dunque finanziamenti a pioggia – secondo il modello della Cassa straordinaria del Mezzogiorno – che oltre a perdersi nei mille rivoli del clientelismo politico e spesso delle reti malavitose, svuotavano di qualsiasi soggettività la Regione. Fin dal 1950 la proposta del Piano di rinascita postulava invece un forte mutamento di politica economica che ovviamente per potersi realizzare necessitava di armonizzarsi con quella nazionale. Così si prospettavano riforme di struttura come la nazionalizzazione dell’energia elettrica e la riforma agraria. Intorno a queste linee si sviluppò un movimento popolare che dopo tredici anni era riuscito a strappare un importante corpo di leggi articolato sul piano regionale e nazionale. Attraverso esse la regione non era relegata al ruolo passivo di destinataria di fondi (la cui entità e finalità è stabilita dallo Stato centrale), ma le viene riconosciuto il potere di partecipare alla contrattazione sugli investimenti pubblici in tutti i suoi aspetti preliminari ed attuativi.
Ma l’aspetto più avanzato, progressivo, del piano era che esso non si configurava come un intervento burocratico formulato da organi meramente tecnici. L’idea del piano era che esso avrebbe dovuto strutturarsi secondo un forte coinvolgimento democratico della Regione, degli Enti Locali, delle comunità. Queste erano le premesse, la concreta realtà politica e l’involuzione del quadro nazionale aveva impedito al piano di essere attuato secondo i suoi principi ispiratori. Al di là dei limiti nell’attuazione, gli effetti positivi del piano erano tutti nel movimento che intorno ad esso si era costituito e nel risveglio democratico che esso aveva suscitato presso municipi e comunità.
In concreto la stagione delle lotte per la Rinascita portò la Sardegna a compiere un indubbio balzo in avanti, anche se va detto per esteso che quel che si realizzò solo in minima parte corrispondeva alle proposizioni del Congresso del popolo sardo. Nelle intenzioni dei comunisti il piano di Rinascita doveva condurre ad una programmazione economica integrata capace di mutare i rapporti sociali di produzione, anzitutto nelle campagne, e sbloccare i meccanismi di accumulazione e distribuzione delle ricchezze. La risposta del Governo a guida democristiana si concentrò invece nella stagione, per molti versi effimera e dannosa, dell’industrializzazione forzata, attraverso la quale la gran parte delle risorse pubbliche vennero dirottate per favorire famiglie potenti come i Morati e i Rovelli e rinsaldare ulteriormente il blocco sociale tra classe politica e capitalismo parassitario del Nord Italia. Dunque una nuova stagione di colonizzazione che se da un lato ha fornito preziosi posti di lavoro, dall’altra ha portato fuori dall’Isola i profitti realizzati lasciando in loco solo il peso ingombrante e inquinante delle produzioni.
* * *
A tanti anni di distanza di quelle lotte resta anzitutto un’eredità che riaffiora carsicamente in diverse battaglie dei giorni nostri, (quella per la restituzione alla Sardegna di ciò che le spetta in termini di entrate fiscali; per la smilitarizzazione; per l’autogoverno del territorio in materia di tutela ambientale e modello si sviluppo; per trattenere e ridistribuire le ricchezze suscitate dal turismo di lusso che lasciano all’Isola solo le briciole dei lavoretti stagionali ecc., ecc.). Dopo la modifica del Titolo V e l’attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislative analoghe a quelle delle Regioni a Statuto speciale, la realtà e le esigenze concrete impongono un lavoro di adeguamento e rilancio del nostro scheletro costituzionale. C’è un intero quadro di interventi, analisi, elaborazione e lotte che va riempito. Ancora una volta sull’autonomia si può trovare il terreno per ricondurre ad unità la trama frammentata della società sarda. Gli ostacoli a tale ricomposizione non vengono, oggi come in passato, solo da un dominio politico ed economico “forestiero”, ma trovano linfa e strumenti di contrasto proprio in parte significativa delle classi dirigenti sarde, in una borghesia abituata a vivere di rendite parassitarie e di un prestigio sociale che non merita.
1 A. Mattone, Velio Spano. Vita di un rivoluzionario di professione, Edizioni della Torre, Cagliari 1978, pag. 107.
2 Il PCS era animato da alcune figure di un certo rilievo nella storia del movimento socialista e comunista sardo, come l’Avvocato Antonio Cassitta che era stato direttore del giornale «Avanguardia», organo dell’organizzazione giovanile comunista. Nella FGCI Cassitta era stato membro della segreteria nazionale e delegato al III Congresso del Comintern. Oltre a lui altre figure importanti erano un altro avvocato, conosciuto per le sue doti di vecchio tribuno socialista, Antioco Mura di Bonorva, e Francesco Anfossi che in Argentina era stato tra i promotori della Lega sarda di Avellaneda.
4 P. Cucchiarelli, A. Giannulli, Lo Stato parallelo. L’Italia oscura nei documenti e nelle relazioni della Commissione stragi. Gamberetti, Roma, 1997.
6 Renzo Laconi, La Sardegna di ieri e di oggi, scritti e discorsi, (1945-1967), EDES, Cagliari, 1988, pag. 225.
11 Antonio Gramsci, I dolori della Sardegna, ed. piemontese dell’ «Avanti!», 16 aprile 1919. In Scritti 1915-1925, Moizzi Editore, Milano, 1976, pag. 177.