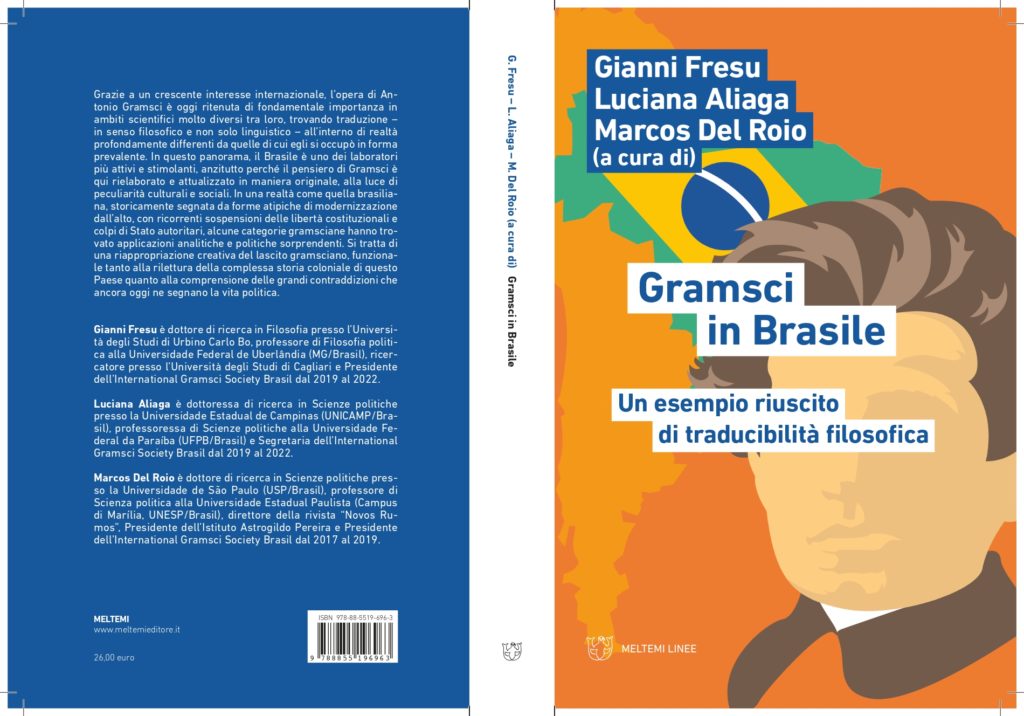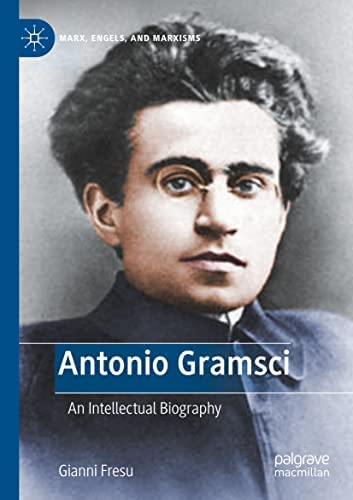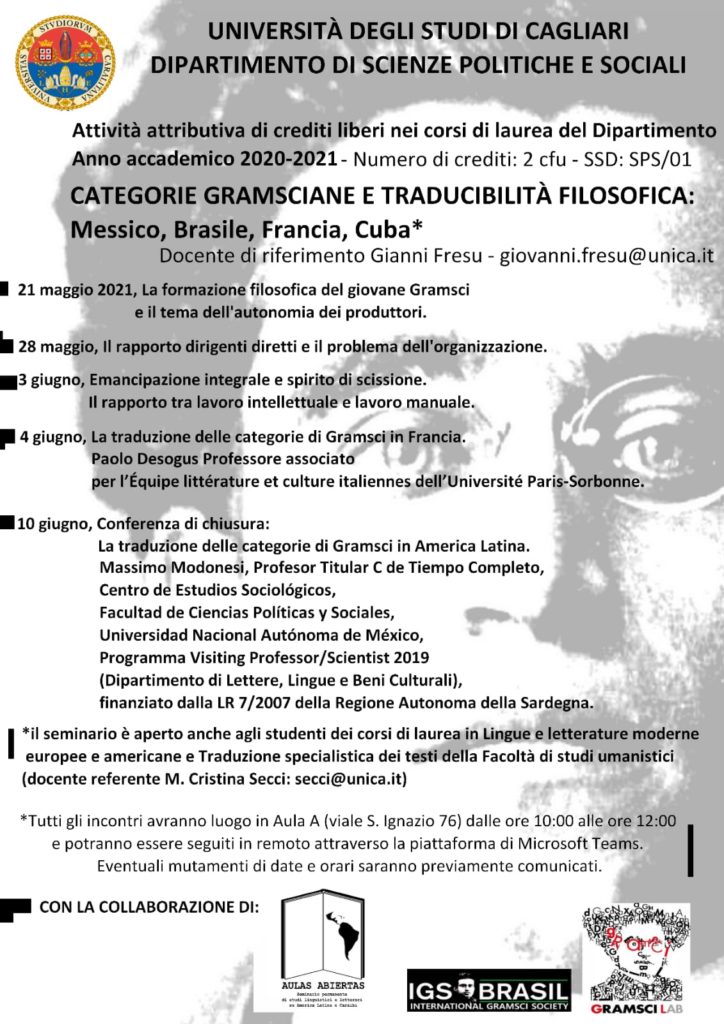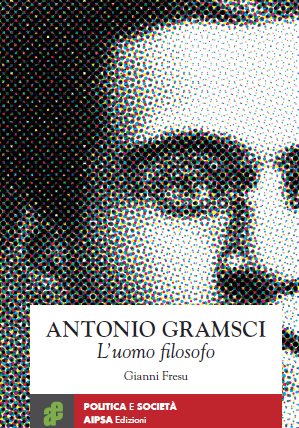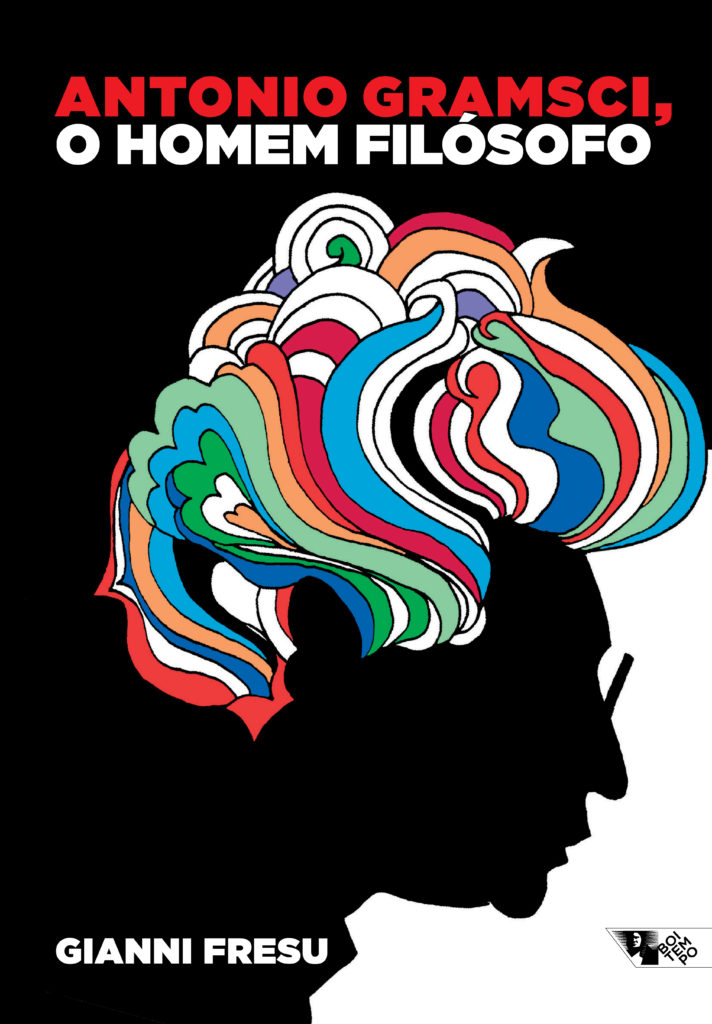Le vicende del PCI si intrecciano strettamente alla costruzione della nostra democrazia repubblicana, a partire dal ruolo assunto da quest’organizzazione nel corso della resistenza e, prima ancora, durante gli anni bui del fascismo trionfante. Tra gli sforzi che il PCI ha condotto con maggior efficacia tra il 1943 e il 1945 c’è senz’altro la lotta contro il cosiddetto “attesismo” di una parte delle forze antifasciste e quella parallela per favorire la partecipazione non solo militare del popolo alla lotta di liberazione nazionale. Il protagonismo nella liberazione del Centro Nord da parte delle divisioni partigiane ha avuto delle conseguenze sullo status post-bellico dell’Italia, contribuendo non poco a un fatto troppo spesso sottovalutato: delle tre nazioni un tempo facenti parte del «Patto tripartito», solo l’Italia vanta una Costituzione frutto di un processo di partecipazione popolare così ampio e socialmente avanzato, non una semplice emanazione degli eserciti occupanti.
Al di là di questo dato di fatto storico, è importante valutare la portata di un simile processo di partecipazione popolare rispetto a una Costituzione che, sia nei primi 3 articoli, sia in quelli di previsione economico-istituzionale, non si limita a disegnare l’impianto di uno Stato gendarme che detta le regole e si limita a farle rispettare. La Costituzione del 1948 nasce con un obbiettivo radicalmente nuovo rispetto al vecchio Statuto prefascista: attribuire alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Come è stato scritto sovente, essa nasce dalla fusione delle tre principali culture politiche del Paese (cattolica, liberale e marxista) sforzandosi di conciliare i concetti di uguaglianza formale e sostanziale, in un nuovo quadro più avanzato orientato al progressivo ampliamento degli spazi di democrazia politica, economica e sociale con il compito di garantire la partecipazione permanente e il protagonismo dei lavoratori nella vita del Paese. Dunque non solo l’idea di libertà negativa, propria della tradizione liberale (la cosiddetta «libertà da»), intesa come intangibilità da parte dello Stato della sfera individuale privata, ma anche quella di libertà positiva, di tradizione democratica e socialista (la cosiddetta «libertà di»), intesa come diritto del popolo a essere parte attiva e protagonista, non passiva e subalterna, dei processi decisionali, nella quale la rimozione degli ostacoli economico sociali all’esercizio dell’effettiva uguaglianza formale assume un ruolo inedito nella storia dell’Italia.
La storia come regolamento di conti
Il mio maestro, Domenico Losurdo, ha dedicato molti studi alla storia del pensiero liberale, tuttavia, il suo lavoro di indagine critica non intendeva disconoscere i meriti e le forze di questa grande tradizione filosofica, ma scegliere il terreno reale della storia, superando le molteplici rimozioni e trasfigurazioni che hanno caratterizzato alcune sue narrazioni apologetiche. Un’analoga cautela metodologica, che evitasse tanto l’agiografia quanto la liquidazione sistematica, non sembra essere stata riservata alle vicende storiche che riguardano il centenario del PCI. Così, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “La Repubblica”, tutte le grandi testate nazionali si sono unite in una nuova Santa Alleanza, cementata dallo stridore di maledizioni che avrebbero dovuto incenerire tutto quel che quella storia ha rappresentato. All’interno di questa narrazione demonizzante, non si coglie nemmeno il più piccolo sforzo per tentare di comprendere l’originalità e la funzione progressiva di questa organizzazione, in un contesto storico denso di contraddizioni interne e internazionali. Va bene prestare attenzione alle contraddizioni, che in quella storia non furono certo poche, ma come si può non avere alcuna curiosità verso la sua ricchezza culturale? Come omettere il suo contributo pedagogico alla socializzazione politica di massa in Italia, ossia al fatto che questo partito è stato comunque strumento di alfabetizzazione e formazione politica, veicolo di partecipazione collettiva per milioni e milioni di “cafoni” (operai, contadini, muratori, lavoratori in genere) fino ad allora esclusi dalla politica e divenuti improvvisamente soggetto attivo e cosciente della vita nazionale? Tutto questo in un Paese storicamente dominato da equilibri sociali regressivi tra le classi, dalle rivoluzioni passive e dal ricorso sistematico al trasformismo che, dal Risorgimento al fascismo, hanno sempre avuto la funzione operativa di escludere e rendere ancora più subalterne le masse popolari. Un pezzo di “riforma intellettuale e morale”, sicuramente incompleto di cui, pur tra mille limiti, quel gruppo dirigente aveva consapevolezza[1].
Ma se veramente questa storia non rappresenta nulla e non ha lasciato tracce, solo fallimenti, perché ogni giorno tutti questi intellettuali in servizio permanente nella difesa dello stato di cose presenti sente il bisogno di mobilitarsi per delegittimarne la memoria e cancellare preventivamente la possibilità di trarne insegnamento per il futuro? Questa volontà censoria, infarcita di scomuniche e maledizioni fino alla settima generazione, ci dice semmai l’esatto contrario di quanto raccontato; in realtà, quelle vicende fanno ancora paura a tanti, sebbene nella politica attuale nessuno abbia ancora avuto la forza, la voglia e l’intelligenza di raccoglierne l’eredità.
Si possono avere diverse opinioni in merito alla sua linea politica, condividerne o meno premesse e prospettive ideologiche, resta innegabile l’importanza di quest’organizzazione di massa nella storia d’Italia del XX secolo. Tale riconoscimento non significa omettere le contraddizioni e i limiti della sua traiettoria politica, ma valutarle unitamente ai contenuti progressivi della sua funzione storica.
La peculiarità del PCI nel panorama del comunismo internazionale, tuttavia, non riguarda solo il suo peso nelle vicende sociali, politiche e culturali di un Paese la cui collocazione nel blocco occidentale era considerata inderogabile, come le trame eversive e la strategia della tensione nel corso del dopoguerra hanno drammaticamente dimostrato. La vera originalità del comunismo italiano riguarda lo sforzo compiuto dai suoi gruppi dirigenti teso a tradurre i principi del marxismo e il contenuto universale della Rivoluzione russa nelle peculiarità della nostra realtà nazionale. Non si trattava di ripetere formule ideologiche generali, né pretendere di riproporre pedissequamente in Italia modelli affermatisi altrove. Come Gramsci scrisse nel Quaderno 7, «il compito era essenzialmente nazionale, cioè domandava una ricognizione del terreno e una fissazione degli elementi di trincea e di fortezza»[2], ossia, inserirsi nelle articolazioni egemoniche della sua società civile, comprendendone l’essenza e originalità.
Fondazioni e rifondazioni
Nella storia del Novecento, le vicende del Partito comunista italiano hanno dato luogo a ricerche e approfondimenti tanto estesi da trovare un corrispettivo solo nel grande interesse verso il Fascismo, sicuramente l’argomento storico-politico italiano più sottoposto a indagine scientifica. Eppure, in questo colossale lavoro di ricostruzione storica ci sono alcune “zone d’ombra” tra le quali spicca senz’altro la mancata o insufficiente storicizzazione della corrente di Amadeo Bordiga, principale artefice e protagonista della nascita del PCd’I. La tendenza a considerare Gramsci il fondatore del “Partito nuovo” è il risultato di una rappresentazione dei fatti strumentale, funzionale alle sue esigenze interne di lotta politica. Tuttavia, cambiato il quadro storico e svanite le necessità dialettiche che ne avevano determinato l’affermazione, una simile visione dei fatti è sopravvissuta allo stesso PCI, così ancora oggi è diffusa l’idea di un “Gramsci padre fondatore del Partito”.
Il PCd’I, Sezione italiana della III Internazionale, nasce a Livorno il 21 gennaio del 1921. A sottolineare con più decisione la sua radice nazionale, a seguito dello scioglimento dell’Internazionale comunista, assume poi il nome di Partito comunista italiano il 15 maggio del 1943. Tuttavia, la scelta di una più netta contestualizzazione nazionale dell’organizzazione nasce ben prima del 1943, con la profonda svolta impressa da Gramsci alla sua direzione politica tra il 1925 e il ‘26. Le Tesi del Congresso Lione del ‘26 sono state definite l’asse fondamentale della sterzata operata nella storia dei comunisti in Italia, sia in rapporto alla concezione del partito, sia per l’analisi della società. In entrambi i casi si giunge al superamento completo delle Tesi elaborate da Bordiga per il Congresso di Roma, dopo il profondo mutamento nella direzione politica del Partito sotto la guida di Antonio Gramsci.
Il Congresso di Lione si svolse nel vivo del secondo colpo di Stato di Mussolini, quando il regime si sbarazzò, definitivamente, delle residue tutele statutarie alla pluralità democratica, cancellando anche per via normativa quelle libertà individuali e collettive già di fatto conculcate. Le Leggi fascistissime posero al vertice dello Stato il Gran Consiglio del fascismo, cui furono attribuiti gran parte dei poteri prima spettanti al Parlamento. Fu istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ripristinata la pena di morte, istituzionalizzata la milizia paramilitare del Partito fascista – rinominata Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – fascistizzati i codici di procedura civile e penale. Soppressi con i partiti e le associazioni, tutti i sindacati, tranne quello fascista. L’occasione per passare alle vie di fatto fu il fallito attentato a Mussolini del 31 ottobre 1926, tuttavia, già in agosto Gramsci aveva previsto la messa fuori legge del partito indicando la necessità di preparare più rapidamente un’efficiente struttura clandestina. Nel giro di poche settimane si mise in moto la macchina repressiva, preparata per via normativa nei mesi precedenti, perfezionando i meccanismi e gli apparati della persecuzione legale delle opposizioni, a partire dall’annullamento di tutti i passaporti per l’estero. Per l’organizzazione comunista, come per tutte le altre forze antifasciste, si aprì il baratro di un’ancora più aperta dittatura poliziesca, un’autentica «caccia all’uomo»[3], strada per strada: le squadre fasciste, ora totalmente coperte dalla legge, devastarono sezioni, sedi di partiti, di sindacati e redazioni di giornali, praticando l’uso indiscriminato del terrore. I vertici del Partito comunista, anzitutto Gramsci, furono arrestati, iniziando il loro calvario nei Tribunali speciali tra le galere e il confino coatto. L’azione repressiva fu estremamente efficace nel dicembre del 1926 un terzo degli aderenti al Partito si trovò in stato di detenzione. Non è questa la sede per affrontare dettagliatamente tali vicende, peraltro ampiamente trattate in numerose pubblicazioni di ricostruzione storiografica e memorie. Basti qui ricordare il punto di non ritorno, scatenato tra il 1926 e il ‘27, per comprendere il clima da cui prende le mosse la fuoriuscita degli antifascisti[4] scampati all’arresto e le immense difficoltà da cui prende le mosse la clandestinità dei temerari che trovano il coraggio di sfidare comunque il fascismo, restando in Patria, con il proposito di opporvisi[5]. In questo clima fu una donna protagonista dell’immediata ricostituzione di un Ufficio di segreteria clandestino, Camilla Ravera, che così ricostruisce l’avvio della vita clandestina in una sua memoria:
In una piccola casa di campagna, nei dintorni di Genova, a Sturla, nel novembre 1926, avevo organizzato la segreteria clandestina del partito comunista: vi si entrava per una strada pietrosa, stretta tra folte siepi e robusti muretti; (…) L’avevo scelta proprio per quel giardino che la isolava e confondeva tra le altre simili sparse in quella campagna. (…) Apparentemente in quella casa stavamo sempre soltanto in tre: io, Giuseppe Amoretti e Anna Bessone. Per dare alla nostra vita un aspetto normale, simile a quello delle famiglie residenti là intorno avevamo preso un’anziana donna del luogo, molto sorda, che ogni mattina veniva due ore a riordinare le stanze occupate al piano terra; quelle del piano superiore figuravano disabitate. (…) Verso sera incominciavano gli incontri, le discussioni fra noi del centro, con i compagni arrivati da altri luoghi. Sovente le discussioni si prolungavano fino a tarda notte; e i compagni di passaggio dovevano essere ospitati nelle stanze superiori della casa, e partire l’indomani alla spicciolata, senza lasciar traccia. Per questo Ignazio Silone aveva dato alla nostra sede il nome di Albergo dei poveri[6].
Tutto ciò è confermato anche dai resoconti del potentissimo ed efficiente capo della polizia Arturo Bocchini, che, nella sua relazione di fine anno, nel 1927, rilevò con soddisfazione come, dopo l’applicazione del Testo unico della Legge di sicurezza pubblica, ogni attività dei partiti di opposizione del regime potesse dirsi totalmente stroncata. Come sottolineato nelle note del “viceduce”, c’era una sola eccezione, il Partito comunista italiano[7]. Quest’organizzazione, nonostante le ondate repressive che di volta in volta decapitarono la sua rete, mantenne sempre un’articolazione clandestina grazie all’afflusso di nuovi aderenti, specie giovani. Tra il 1926 e il ‘43, sui 4.671 condannati dal Tribunale speciale fascista, 4.030 erano membri del partito comunista, mentre dei 28.671 anni di carcere comminati, quasi 24.000 riguardarono suoi dirigenti e militanti[8].
Come è noto, a partire dalla fine degli anni Trenta e soprattutto nella lotta di liberazione nazionale il Partito comunista diviene un soggetto politico capace di attrarre studenti, operai, artisti, letterati, docenti universitari. Da piccolo partito di quadri, presente, e limitatamente, solo in determinate realtà del Paese, diviene la principale organizzazione politica della Resistenza, fino a risultare inaspettatamente il primo partito della sinistra italiana e il più grande partito comunista del campo occidentale.
Sembra quasi impossibile una simile trasformazione, tenuto conto della marginalità e della cultura minoritaria al momento della sua nascita e negli anni di affermazione del Fascismo. Una prima spiegazione andrebbe ricercata forse nella già citata tenacia con cui, anche negli anni più duri della repressione fascista, il PCd’I si sforzò di mantenere in Italia una sua struttura operativa clandestina, anziché limitarsi a trasferire all’estero tutta la sua organizzazione. Tuttavia, sebbene importante, la presenza ostinata dei comunisti nel Paese lungo tutto il ventennio mussoliniano non spiegherebbe da sola un fenomeno di crescita tanto esponenziale. Su esso ha probabilmente influito anche l’evoluzione della sua linea, capace di abbandonare gli approcci settari e minoritari delle origini fino ad aderire con maggiore plasticità alle condizioni nazionali, divenendo un partito di massa per molti versi erede della tradizione organizzativa e sociale del vecchio socialismo.
Transizione
Le Tesi di Lione rappresentano uno spartiacque essenziale, sicuramente il punto più alto nel quale l’elaborazione teorica e la direzione politica di Gramsci trovano un punto d’intesa elevatissimo. Nella biografia di Gramsci queste rappresentano un punto di continuità tra le battaglie precedenti il 1926 e le riflessioni carcerarie, la testimonianza più vivida di quanto sia impossibile separare il Gramsci politico e militante dal Gramsci “disinteressato” o “uomo di cultura”. La svolta di Lione costituisce la premessa essenziale per comprendere il ruolo storico assunto dal PCI tanto nella Resistenza, quanto nella fase successiva alla Liberazione; è l’antefatto più pregnante del profondo mutamento nell’iniziativa dei comunisti tra il VII Congresso del Comintern e la “svolta di Salerno” del 1944. Il risultato più fecondo di questa svolta fu il concepire in termini organici le tematiche della lotta al fascismo e quelli della ricostruzione democratica a partire dalla stagione costituente. Il punto d’intesa tra questi due momenti era l’idea della democrazia progressiva, vale a dire, la prospettiva di un permanente allargamento degli spazi di democrazia economica, sociale e politica, tali da consentire al mondo del lavoro di conquistare posizioni di forza, in un processo di transizione democratica al socialismo.
Questione nazionale
Bisognava rimuovere le radici economico sociali del fascismo, ossia la natura monopolistica di un certo suo capitalismo, il parassitismo oligarchico, causa congenita del sovversivismo reazionario di parte significativa delle sue classi dirigenti. Per raggiungere questo obiettivo, così come per quello propedeutico della liberazione dell’occupazione nazifascista, era essenziale trovare un’intesa unitaria con le altre forze popolari del Paese, non solo i socialisti ma anche e soprattutto le masse cattoliche. Al di là di miti e leggende sulla presunta “doppiezza togliattiana”, nella scelta operata con la svolta di Salerno nel 1944, e in quelle successive, fino all’approvazione della Costituzione repubblicana non c’era alcun “abile espediente tattico”, si trattava di scelte strategiche conseguenti alla ricerca di un’originale via italiana al socialismo, frutto delle specificità storiche, culturali e sociali della concreta realtà nazionale in cui i comunisti intendevano agire.
A prescindere dalla nostra visione del mondo, dall’aderire a questa o a quella tendenza storica, l’insieme di tali vicende meriterebbe maggior attenzione e rispetto, non tanto per assolvere alle legittime e pur importanti esigenze commemorative, ma per meglio comprendere le origini della nostra democrazia repubblicana e il travaglio umano che la generò, dunque, mi permetto di aggiungere, anche per difenderla con più convinzione e cognizione di causa da ogni attacco o tentazione di involuzione autoritaria.
Gianni Fresu